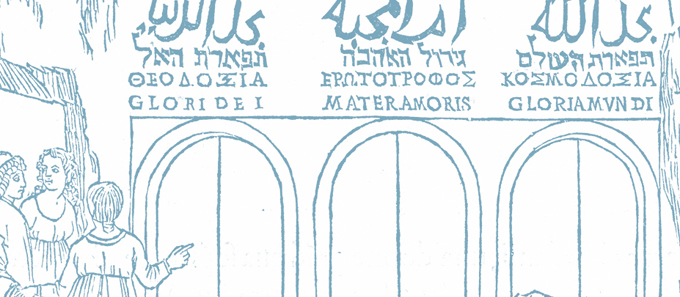Musiche (e musicologie) del XXI secolo
Diritto d’autore nelle musiche di tradizione orale: una nuova questione etnografica
La questione della tutela del diritto d’autore è da lungo tempo oggetto di interesse dell’etnomusicologia, dato che per lungo tempo le normative a livello internazionale non hanno previsto particolari garanzie per opere che sono il frutto della tradizione orale e di una creazione condivisa. Già Carpitella, in Italia, segnalava negli anni Settanta il problema indicando come andassero individuate soluzioni per tutelare anche le musiche di tradizione orale nell’ambito dell’attività della SIAE e, di converso, riconoscere diritti, anche sul piano economico, agli esecutori-creatori di tali musiche. Anche organizzazioni internazionali come l’Unesco e l’IMC hanno riflettuto a possibili soluzioni senza raggiungere risultati soddisfacenti nonostante le numerose risoluzioni adottate in diversi incontri internazionali, anche perché tali risoluzioni sono state raramente applicate in passato. Negli anni Novanta e Duemila, sotto la spinta della World Music, è nato un nuovo movimento di pensiero, soprattutto negli Stati Uniti, volto alla tutela e al riconoscimento, anche economico, dei diritti dei musicisti extraeuropei nei confronti del mercato discografico e degli artisti mainstream della popular music, rilevando come le operazioni di campionamento digitale e la diffusione su internet costituissero un’enorme potenziale risorsa ma anche un grande rischio. Nel 2001, inoltre, fu proprio il Seminario Internazionale di Etnomusicologia dell’IISMC curato da Francesco Giannattasio ad affrontare la questione nell’ambito della World Music.
[accordion]
[accordion_entry title=”Continua”]
Oggi questi disequilibri si sono in parte attenuati in una situazione che rimane comunque confusa e con normative carenti a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, la questione si va configurando in maniera diversa rispetto al passato, ivi compreso il rapporto tra musicisti e ricercatori. Se, fino a poco tempo fa, il ricercatore si poneva il problema della tutela di musicisti inconsapevoli dei meccanismi alla base della distribuzione delle risorse del diritto d’autore e sosteneva il riconoscimento dell’autorialità anche a musicisti che non fanno uso della scrittura, in questi anni i contesti nei quali vengono eseguite le musiche di tradizione orale pongono al ricercatore nuove questioni etnografiche. Sono infatti i musicisti stessi che “depositano” le proprie musiche o le denominazioni tradizionali delle proprie musiche nelle sedi legali, in tal modo innescando sul territorio dinamiche nuove e peculiari.
Su queste dinamiche il Seminario intende riflettere considerando come, all’interno di una circolazione della musica – anche di quella cosiddetta tradizionale – sempre più spettacolarizzata, patrimonializzata e mediatizzata, i musicisti rivendichino la propria autorialità a volte anche in parte “appropriandosi” di patrimoni collettivi e condivisi dalla loro comunità di riferimento. Se da un lato essi hanno ragioni da vendere in relazione al mercato della musica, dato che il loro ruolo è stato per tanto tempo sottovalutato o affatto riconosciuto, dall’altro la loro azione individuale può portare a contrasti e contraddizioni molto forti nel loro ambito di riferimento, dato che ciò che essi suonano è in parte frutto della propria creatività e autorialità e in parte patrimonio condiviso secondo i modelli di creazione e circolazione collettiva delle musiche di tradizione orale che i demologi e gli etnomusicologi studiano e descrivono da lungo tempo. In tale prospettiva il ruolo del ricercatore cambia radicalmente dovendosi egli spesso misurare con istanze individuali di musicisti e con contesti fortemente dialettici nei quali è a volte anche chiamato a intervenire. Si pone così la nuova questione etnografica menzionata nel titolo di questo seminario: in che modo e fino a che punto le musiche di tradizione orale possono essere considerate prodotto della creatività individuale piuttosto che di una comunità che ne condivide le pratiche performative? Quali sono le dinamiche che si innescano a livello locale a seguito di questi nuovi scenari? In che modi e in che forme va regolamentato, in un delicato equilibrio, il riconoscimento (autoriale ed economico) del processo creativo e di rielaborazione di una tradizione dei musicisti e salvaguardato allo stesso tempo il diritto di una comunità di sentirlo come patrimonio comune?
[/accordion_entry]
[/accordion]
Programma dei lavori:
Giovedì 25 gennaio 2018
9.30-12.30
Giovanni Giuriati
Introduzione
Giovanni Giuriati e Beniamino Palmieri
La tarantella di Montemarano e i suoi diritti
Mariano Fresta
Dell’esistenza della proprietà intellettuale nel folklore. Il caso dei bottari di Macerata Campania
14.30-16.30
Ignazio Macchiarella
“A cada bidda su suo”. Questioni di “proprietà della musica” in Sardegna
Venerdì 26 gennaio 2018
9.30-12.30
Naila Ceribasic
Safeguarding intangible cultural heritage – a route towards protecting collective intellectual property rights?
Federica Mucci
La protezione internazionale del patrimonio culturale intangibile, “vivente” nelle comunità e nei singoli individui, tra difficoltà definitorie e tutela della creatività: la musica costantemente ri-creata
14.30-16.30
Lars-Christian Koch
Copyright and the Construction of Sonic Identities – Reflections on Scientific Sound Archives
18.30-20
Concerto con I Solisti di Montemarano e Pastellesse sound group
Bottari e tarantelle. Musiche per il Carnevale in Campania
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Sabato 26 gennaio 2018
9.30-13.30
Italo Mastrolia
Musica di tradizione orale: lacune nella tutela giuridica del bene culturale immateriale e possibili rimedi, tra definizioni teoriche e disegno storico
Silja Fischer
IMC’s five music rights and copyright, a holistic approach