CIAC – XXXIII CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA CULTURA
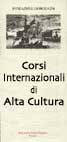
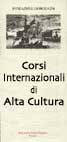
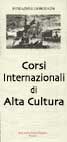
Nel 1993 ricorre il duecentocinquantesimo anniversario dell’arrivo di Jean Jacques Rousseau a Venezia, segretario dell’Ambasciatore di Francia, e insieme il duecentesimo della morte a Parigi di Carlo Goldoni, che trascorse l’ultimo periodo della sua vita nella capitale francese.
Goldoni e Rousseau, tra Venezia e l’Europa: la riflessione e la rappresentazione di una civiltà che, nel conoscersi matura, critica i propri limiti e si consegna – fervida o sorridente, ignara o riottosa – al proprio rinnovamento, a un rito palingenetico e sacrificale. E tuttavia indugia sui propri costumi, sul luoghi interni ed esterni (dal salotto al “cabinet de lecture”, al caffè, alla piazza) del proprio conversare. Studia i temperamenti, educa i sentimenti, celebra la ragione, riforma gli stati, nutre utopie: nulla lascia in ombra della ‘macchina’ dell’uomo e della società. E insieme agli “emblemi della ragione” si compongono le “arie del sonno”, i paesaggi del sogno, le promenades e le révertes in cerca di sé.
Questo il percorso, lungo il doppio viaggio di Rousseau a Venezia e di Goldoni a Parigi, che il XXXV Corso di Alta Cultura propone, tra le ragioni del ‘cuore’ e le ragioni dei lumi nel maturo Settecento europeo.
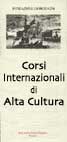
“Dall’Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno”. La carta d’identità dell’Europa si è variamente disegnata nei due millenni della sua storia di mito politico, unito da una sola lingua e un solo stato. Se la Grecia di Alessandro guarda ad Oriente, l’Europa dell’Impero Romano andrà dall’Egitto alla Scozia. E dopo Roma, ogni ritomo di mito imperiale – da Carlo Magno a Carlo V, da Napoleone a Hitler, questa estrema degenerazione del mito unitario – non potrà fare a meno del miraggio di un’Europa indivisa.
Ora che col trattato di Roma se ne sono posti i fondamenti, con quello di Maastricht se ne delineano in concreto forme e tempi di attuazione come unità economica e speranza politica, e con la fine del muro di Berlino si riaprono gli antichi orizzonti di una mai perduta vocazione unitaria, il XXXVII Corso di Alta Cultura della Fondazione Giorgio Cini intende proporre e ripercorrere momenti significativi di quei miti di identità.
Cominciando dalle capitali che l’hanno animata: Roma, prima di tutto,Venezia, Anversa, Parigi, Berlino; ma poi via via altre visioni e miti susseguitisi nel tempo, fino alle ultime proiezioni della leggendaria mitologia d’Europa, quasi l’origine e il compimento della storia.
E accanto ad esse, figure, situazioni e immagini che questa mitologia hanno incarnato, proposto o interpretato: dall’ideologia dell’Impero Romano nella riflessione di Sant’Agostino alla visione dell’Europa degli umanisti, dalle immagini vichiane a quelle dell’Illuminismo, dai sogni unificatori dell’impero ispanico a quelli del totalitarismo del XX secolo, a momenti di unità culturale nelle arti figurative e nella musica, a figure emblematiche della creatività letteraria (da Don Chisciotte a Don Giovanni a Faust). Ristudiare in una parola il mito d’Europa per ritrovare un antico destino d’Occidente: governare il tempo, modellando lo spazio nella Memoria.
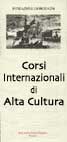
Mentre l’Europa, nel progredire della Rivoluzione francese e dilagare delle armate napoleoniche, cominciava a prendere coscienza della fine dell’Antico Regime, già si chiudeva l’epopea della Serenissima: un tramonto che preannunciava un nuovo giomo.
Un secolo più tardi, mentre da più parti in Europa si avvertivano i primi segnali del “declino dell’Occidente”, Venezia – da Wagner a Maurras, da D’Annunzio a Thomas Mann – tutti a sé evocava, facendosi emblema e paradigma estremo del declinare di una civiltà.
Ma, già secoli prima, mentre l’Oriente era ancora il ricettacolo di mostri e prodigi,Venezia inviava, per mercatura e scienza, su quelle vie i suoi naviganti. Mentre l’acqua ancora era nemica e strade e borghi si edificavano sui colli, Venezia costruiva sull’acqua: inventava spazio, non s’arroccava in esso.
Al chiudersi di un millennio di trasformazioni, irreparabili cadute, riapparizioni e metamorfosi, il corso intende esplorare e approfondire alcuni momenti più suggestivi di queste oscillazioni di civiltà, arresti e riprese di destino, dai drammi talora senza presagi di futuro delle epoche antiche agli sconvolgimenti non ancora chiaramente decifrabili del secolo presente.Come suggerisce l’emblema rinascimentale, “recisa – Venezia – rinasce”, e ricorderà più tardi Gide (“Si le grain ne meurt…”), dalle origini della nostra civiltà, ogni fine, ogni morte, ogni esodo è sempre stato atteso e attraversato come necessario transito verso nuove apocalissi e risurrezioni.

Qual è la città sulle montagne
Si spacca e si riforma e scoppia nell’aria viola
Torri crollanti
Gerusalemme Atene Alessandria
Vienna Londra
Irreale
così giunge al Novecento, alla Terra desolata di T. S. Eliot, il biblico anelito del Salmo 121, in vista del monte Sion:
E ora i nostri piedi sostano
alle tue porte, Gerusalemme!
Chiedete pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano
sia pace sulle tue mura
Alla vigilia dell’anno giubilare, il Corso ripercorre nei testi e nei miti delle “Città eterne”, città sacre e luoghi di pellegrinaggio, di voti e di desideri, di invocazioni e soste, il ricorrente anelito umano di “dar luogo” al divino, di fornire all’invisibile una dimora terrena. Dall’Itinerarium Egeriae alla Topographie légendaire des Evangiles en Terre Sainte di Maurice Halbwachs, dalla prima opera giubilare, la Divina Commedia di Dante, alle Storie della città di Dio di Pier Paolo Pasolini, da Roma a Gerusalemme, da Kyoto a Benares, da Compostela alla Mecca, dall’Occidente all’estremo Oriente, l’uomo di questi due millenni trascorsi non ha fatto che viaggiare cercando il tempo e il luogo in cui tempo ed eternità si congiungessero ed egli trovasse sonno terreno e veglia nel sempre, la sua agognata dormitio.
Il Corso ripercorre quei passi e quei canti, quei viaggi e quegli aneliti, nelle lingue che son trascorse, nei monumenti che rimangono:
Alta, lei. Alta
Sopra di sé.
Scavata
in che miniera
di luminosità
quell’altezza, dico
che la eleva –
la alza vertiginosamente
e la spiomba su se medesima
a formare la basilica,
la nostra, lasciata
al putiferio della mortalità – e che pure,
e che pure mortale non ci sembra…
(Mario Luzi, Eglise)
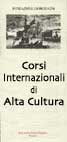
La manifestazione avviene nel quadro delle celebrazioni del cinquantenario della Fondazione Giorgio Cini 1951 – 2001.
I grandi rivolgimenti storici e i grandi compimenti statuali sono stati preparati o suggellati da chartae, dichiarazioni, elencazioni di princípi, e infine costituzioni. L’Europa a venire è erede di molteplici manifesti di intenti, che la recente Charta, proposta a Nizza, eredita e riflette.
Il Corso vuole ripercorrere e studiare questa pluralità, nella continuità degli accenti, o nella marcata specificità dei movimenti storici: da Carlo Magno alla Rivoluzione francese, dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo agli emblemi riassuntivi di una identità collettiva: inni e bandiere, feste e giuramenti, sino alle presenti difficoltà di ridurre ad unità una pluralità contesa, di lingua, di dialetti, di tradizioni, di costituzioni.
Paesaggio, décor, fondali, «lontani», esterni, vedute, atmosfere, notturni: ogni modo di definire ciò che ci circonda implica anche un giudizio sul nostro modo di essere, ci situa nello spazio come relazione. L’arte, tutte le arti, così come la riflessione filosofica, il senso della condizione esistenziale, e il configurarsi e mutare di segno della particolare presenza umana in esso, hanno, da sempre, sentito e dovuto affrontare il problema: la nascita, o la lenta scoperta, del paesaggio, il suo collocarsi e trasmutare, il suo dominare la scena dell’espressività, fino alla fuga nell’esotismo, forse al suo dissolversi, e al possibile ricostituirsi. Il farsi e il disfarsi del paesaggio sarà studiato in questo corso, con più approfonditi sondaggi, nell’evoluzione delle arti e nel loro intreccio, in quelle figurative e plastiche, nella letteratura, nella musica, nella storia delle mentalità e delle idee, nei processi consci ed inconsci, dalla percezione alla descrizione, al simbolo, alla metafora, in una vicenda che ha accompagnato lo svolgersi del rapporto dell’uomo con la realtà di cui è parte.

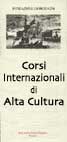

Il Corso di Alta Cultura opera le proprie scelte anno per anno, tenendo anche presenti particolari ricorrenze storiche (di eventi o di anniversari di grande importanza) oppure l’affiorare nell’evoluzione della cultura mondiale di interessi o di problematiche nuove, l’aprirsi o il chiudersi di situazioni o di problemi storici che hanno particolarmente inciso sulla società del nostro tempo.Nell’imminenza del 1997 – e, com’è uso in questi casi a San Giorgio, con opportuno anticipo – si coglierà l’occasione della bicentenaria ricorrenza della fine della Serenissima Repubblica. Una ricorrenza che verrà doverosamente ricordata dalla Fondazione che a Venezia è sorta e che alla civiltà veneziana ricollega la maggior parte delle sue iniziative – non prendendo in considerazione solamente gli eventi politici quanto ponendo a fuoco causalità prossime e remote, le condizioni interne e internazionali di quel momento storico, l’evoluzione o il tramonto delle ideologie settecentesche, lo sfaldarsi delle istituzioni politiche e sociali della Repubblica, i nuovi orientamenti della vita non soltanto politica ma soprattutto economica e culturale di Venezia e la nuova vocazione della città nel corso dell’Ottocento, prima e dopo l’Unità.
Una visione il più possibile articolata nei limiti della durata del corso, delle problematiche intorno a Venezia nei suoi vari momenti, che miri a dare il senso “storico” di quel che la Repubblica ha significato, i modi della vita sociale, l’evoluzione delle istituzioni culturali, i mutamenti intervenuti per quel che riguarda la città e la sua funzione nel quadro delle nuove realtà, alcune delle figure più importanti nell’arte, nelle lettere e nella cultura, da Tiepolo a Casanova, da Canova al Foscolo, gli eventi culturali e le trasformazioni di percezione che la parola Venezia suscita.
Il Corso Internazionale di Alta Cultura è un’iniziativa comune della Fondazione Giorgio Cini e della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia. Esso è parte di un progetto di collaborazione fra le due Fondazioni nell’attività di formazione, il quale comprende l’insieme dei corsi e delle manifestazioni ad essi collegate che si svolgono lungo l’anno nell’isola di San Giorgio Maggiore.
Volume Le metamorfosi di Venezia, da capitale di stato a città del mondo