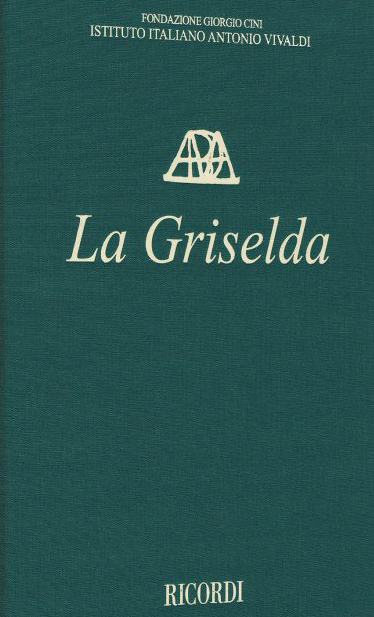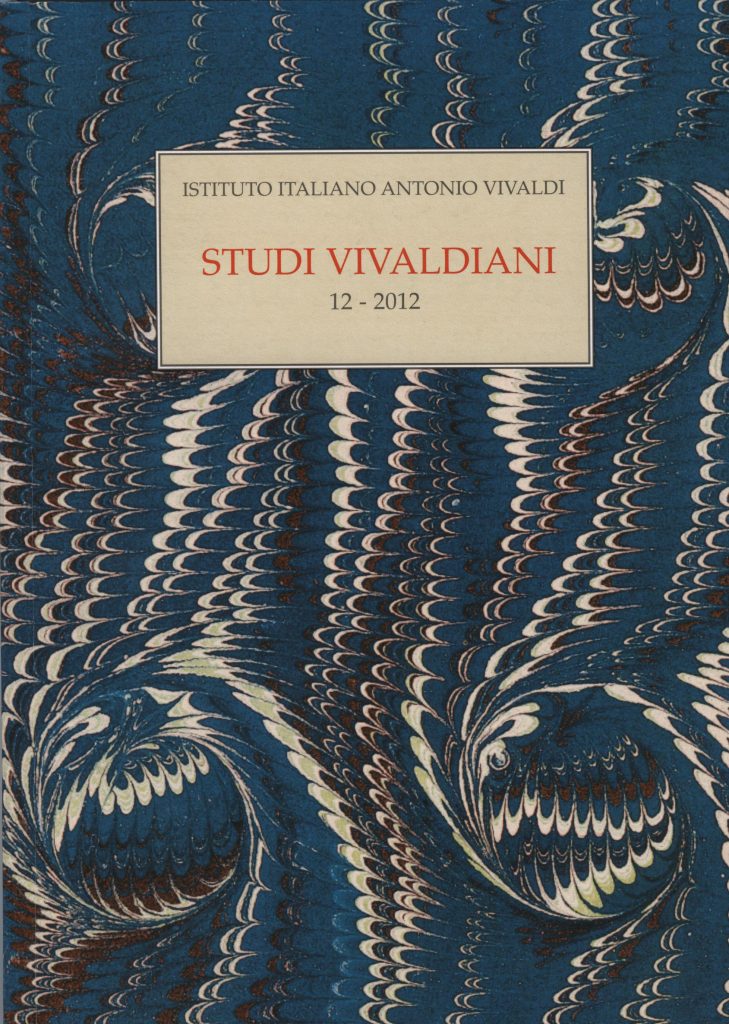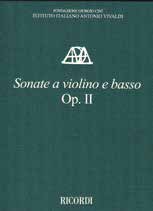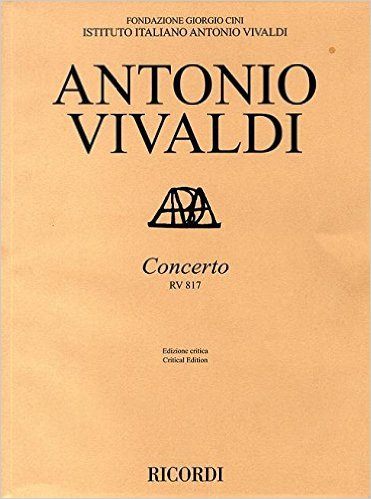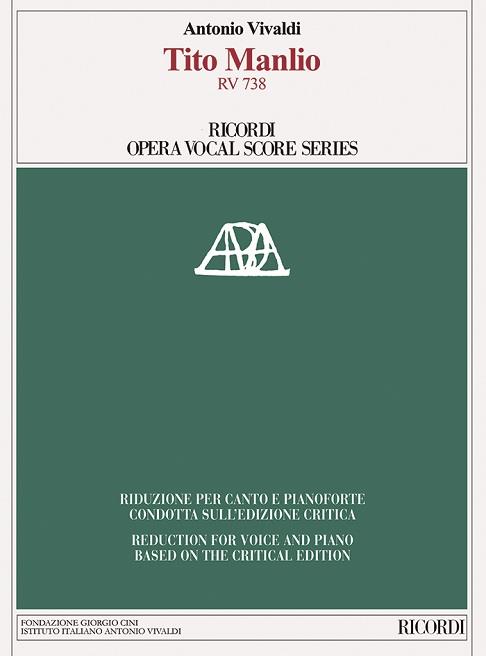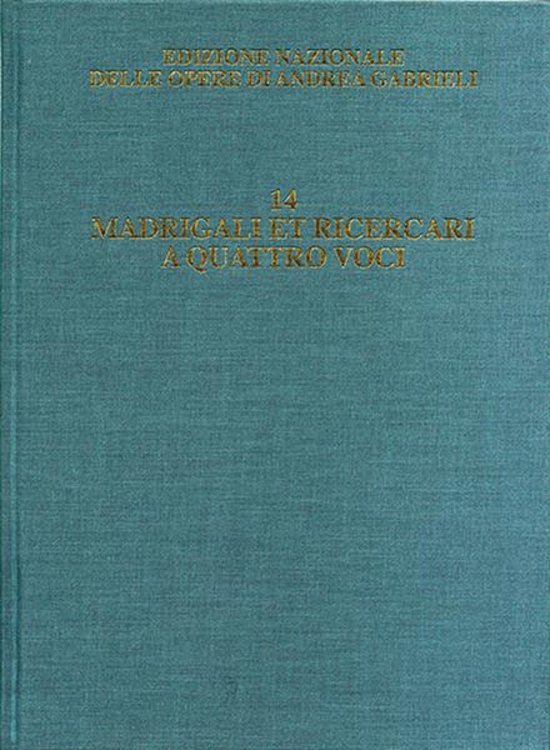Antonio Vivaldi
La Griselda, RV 718
Edizione critica a cura di Marco Bizzarini e Alessandro Borin
Collana “Edizione critica delle Opere di Antonio Vivaldi”
Editore Ricordi, Milano, 2015
La Griselda, RV 718, fu composta e rappresentata a Venezia, nella primavera del 1735, in occasione della fiera della Sensa (Ascensione). Il compito di adattare il libretto di Apostolo Zeno alle particolari esigenze della messinscena fu affidato a un giovane commediografo della compagnia di Giuseppe Imer, Carlo Goldoni. Questi immortalò nei suoi Mémoires l’incontro con Vivaldi e la sua inseparabile primadonna, il contralto Anna Giraud, confessando di aver dovuto «assassinare» suo malgrado il dramma zeniano a capriccio del compositore. La Griselda, che a dispetto delle querimonie di Goldoni fu accolta con favore dal pubblico del San Samuele, restò il solo melodramma vivaldiano messo in scena in un teatro della potente famiglia Grimani. L’edizione critica della partitura è preceduta da una scelta di riproduzioni fotogra- che del manoscritto autografo e accompagnata da una ristampa anastatica completa del libretto. I testi a corredo dell’edizione, pubblicati in un volume a parte, comprendono un’Introduzione storica e un Apparato critico che registra e discute tutte le varianti attestate nelle fonti principali e secondarie collazionate.