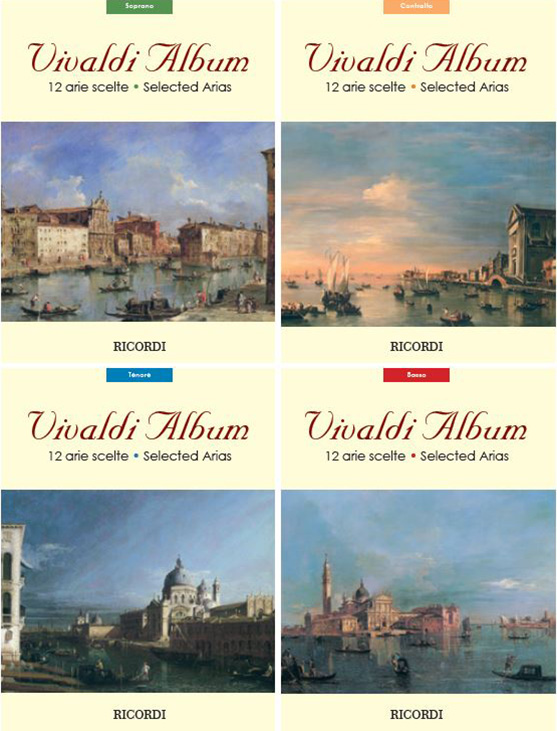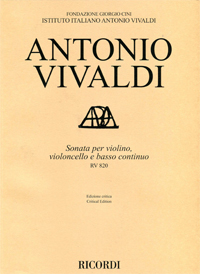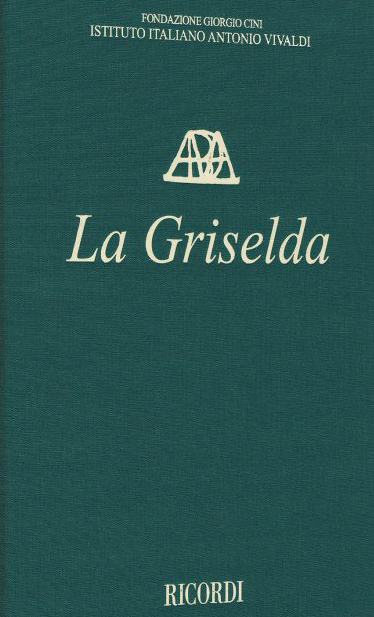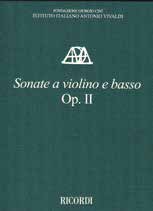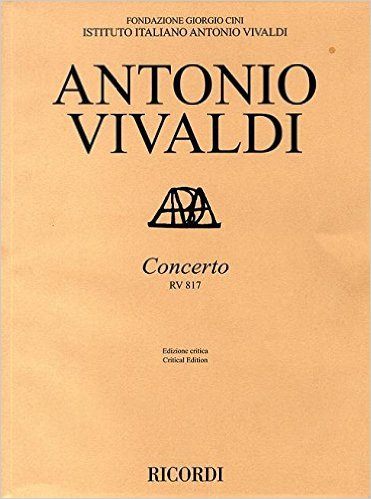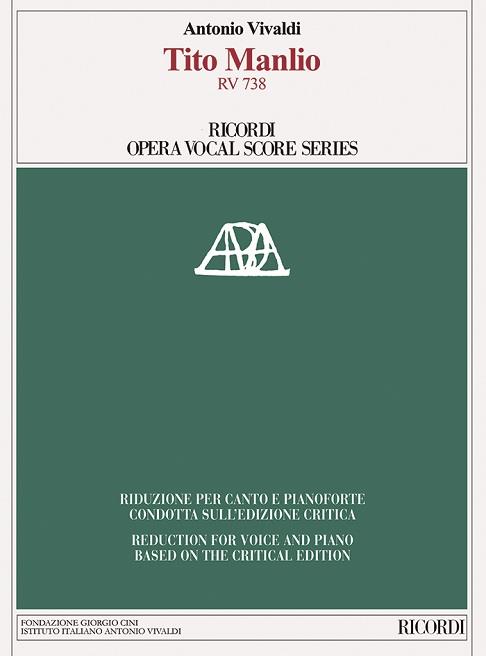«Vivaldi Album» è una serie di antologie di arie d’opera, suddivise per registri vocali, tratte dal corpus delle musiche teatrali di Antonio Vivaldi sopravvissute fino ai giorni nostri. Questo repertorio annovera ventiquattro drammi per musica, tre serenate e un ingente numero di arie sciolte. Ciascun volume comprende dodici brani, diversificati per affetto e carattere, che esemplificano una pluralità di stili e di situazioni drammatiche, disposte in ordine cronologico, così da rappresentare uno spaccato ideale dell’intera carriera di Vivaldi.
Le dodici arie contenute in ciascuno dei quattro volumi sono tratte da altrettante produzioni operistiche, che coprono un arco cronologico di circa un quarto di secolo: dall’esordio vicentino (1713) alle opere più mature, rappresentate alla fine degli anni Trenta del Settecento. Oltre che per la varietà e l’intrinseco valore musicale, i titoli raccolti all’interno del volume sono stati scelti perché rappresentano uno spaccato ideale dell’intera produzione vivaldiana per il teatro d’opera: alcuni brani risalgono infatti alla prima fase della sua carriera, legata soprattutto al rapporto col teatro veneziano di Sant’Angelo, la maggior parte al periodo di mezzo, coinciso con una serie di scritture ottenute presso le più importanti corti italiane dell’epoca (Mantova, Firenze, Milano, Roma), e altri ancora alla fase conclusiva della sua attività, allorché la diaspora dei musicisti napoletani verso il nord della penisola, e Venezia in particolare, lo aveva costretto a decentrare il suo raggio d’azione verso la Terraferma veneta. Solo alcune delle partiture da cui sono tratte le arie pubblicate in questa antologia ci sono pervenute in forma completa o prossima alla completezza; la maggior parte di esse, infatti, è caratterizzata da un grado di incompiutezza più o meno accentuato, oppure è sopravvissuta esclusivamente allo stato di abbozzo, come semplici residui di opere in gran parte perdute.