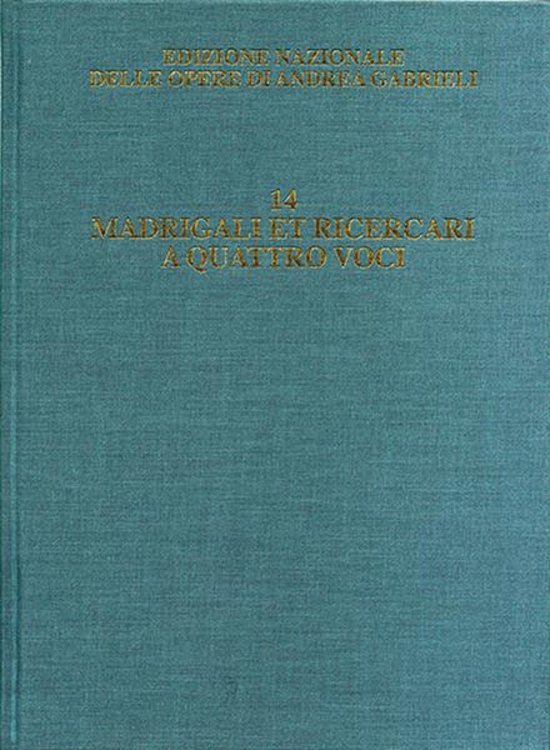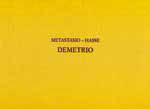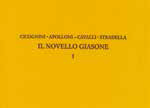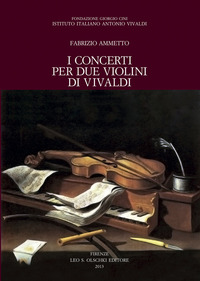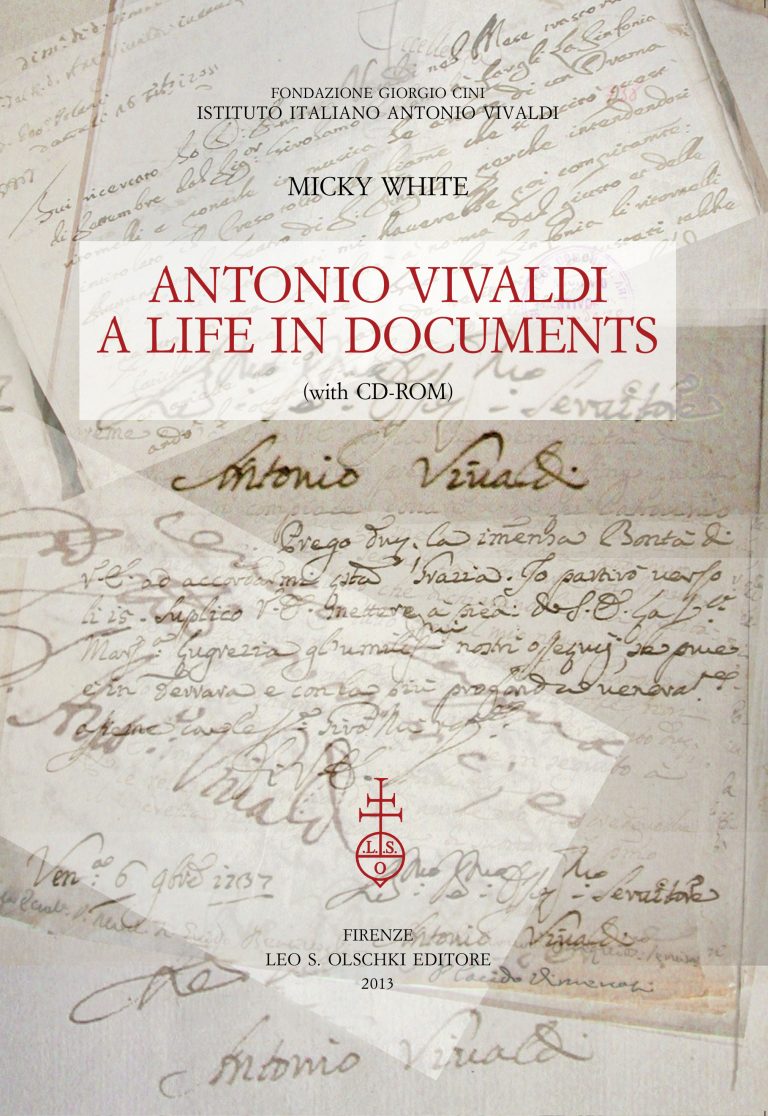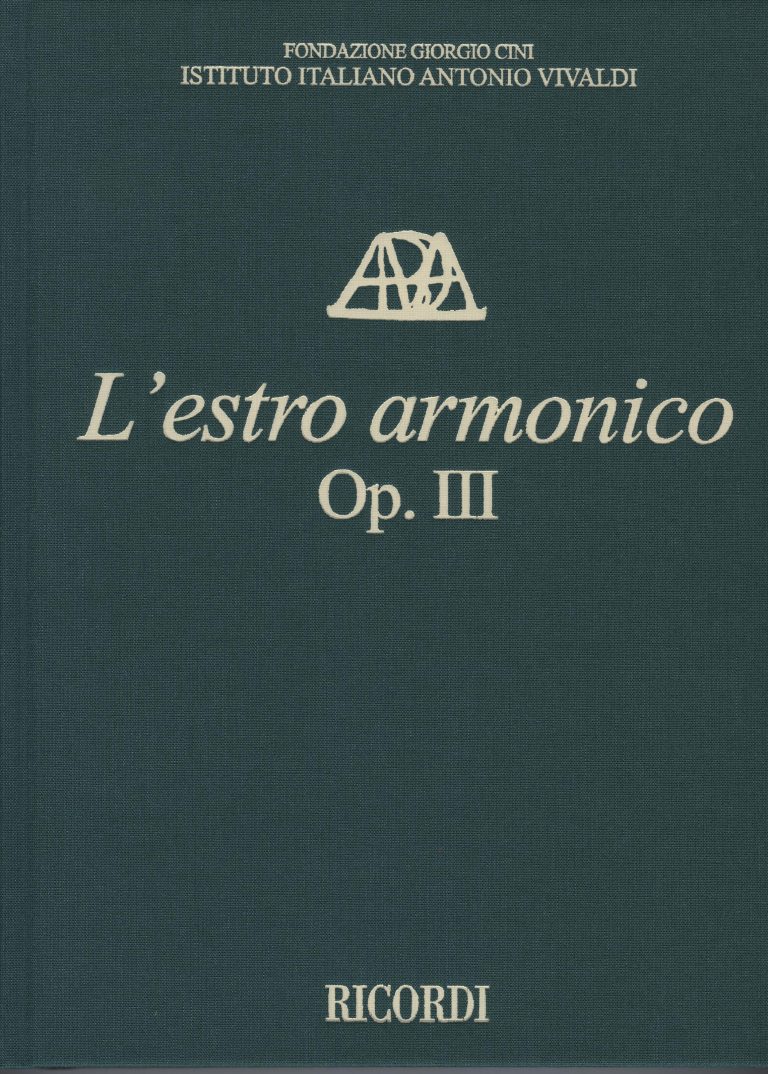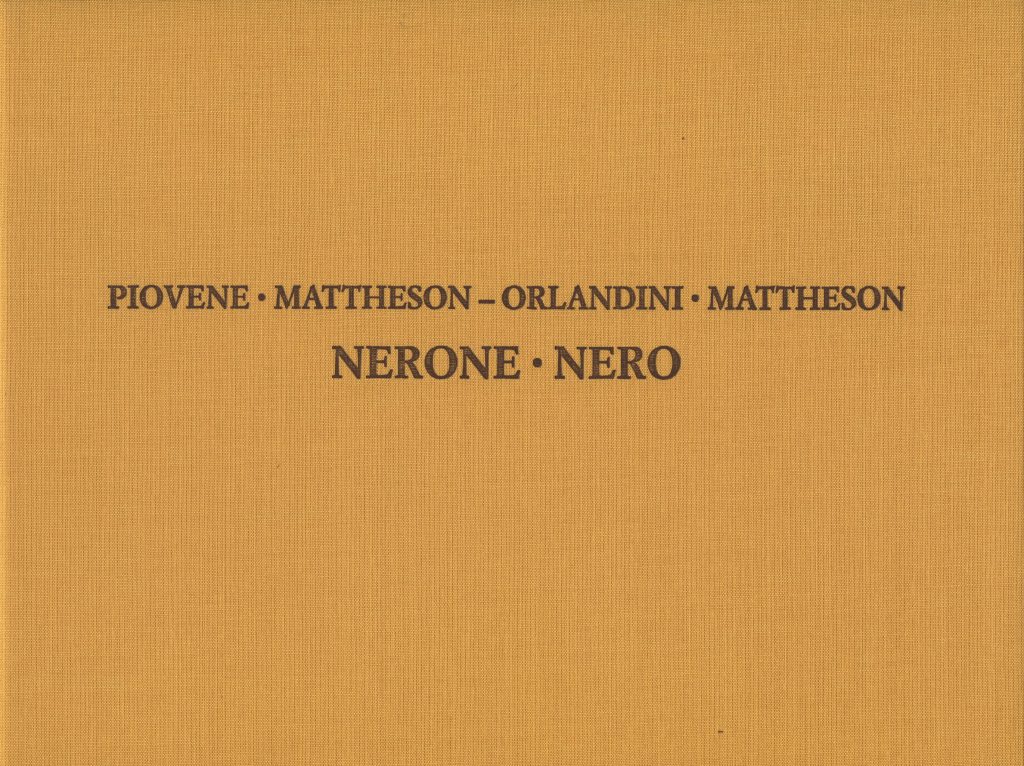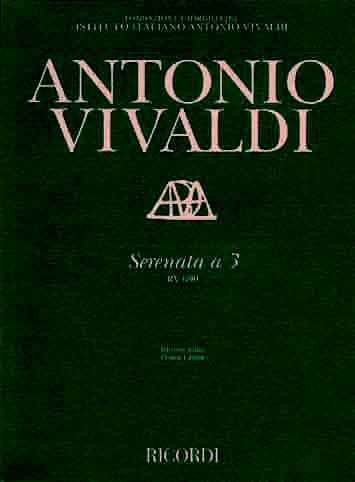Andrea Gabrieli
Il primo libro de madrigali a sei voci
Edizione critica a cura di Alessandro Borin
“Edizione Nazionale delle opere di Andrea Gabrieli”, 5
Ricordi, Milano, 2014
La presente edizione critica si basa sulle due edizioni de Il primo libro de madrigali a sei voci, pubblicate a Venezia rispettivamente nel 1574 e nel 1587. La princeps, dedicata al mecenate bolognese Giovanni Saraceni, comprende diciotto madrigali il primo dei quali, in lode del dedicatario, fu sostituito nella ristampa da due componimenti – sempre a sei voci – gia pubblicati nel Secondo libro di madrigali a cinque voci (1570). Nella Prefazione al volume si forniscono brevi accenni storico-stilistici sulla natura dei legami di Gabrieli con la famiglia Saraceni, sui circoli letterari veneziani in cui furono concepiti i testi intonati in questa raccolta e sui modelli che potrebbero aver influenzato alcune scelte musicali di Gabrieli. Nelle Note critiche si fornisce la descrizione analitica dell’editio princeps (testimoniata in sole due copie complete, conservate presso la Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt di Kassel e la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera) e della ristampa postuma (quattro esemplari completi sopravvissuti), oltre a un elenco cronologico delle fonti concordanti, che includono dei travestimenti spirituali e delle versioni diminuite di brani pubblicati nella presente raccolta (fra cui il celebre trattato Il vero modo di diminuir […] di Girolamo della Casa, le cui esemplificazioni sono stampate in Appendice a questo volume).