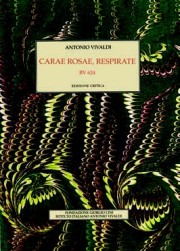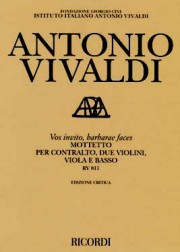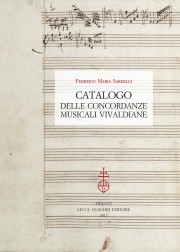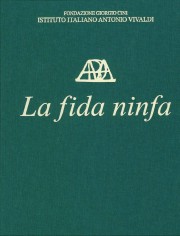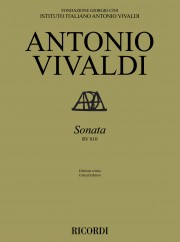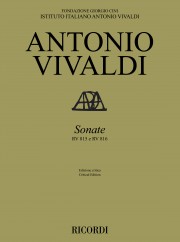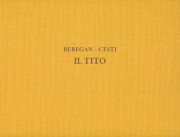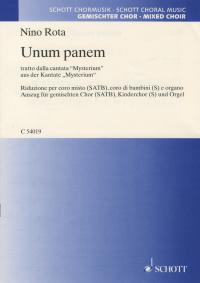Carae rosae, respirate, RV 624 è il solo mottetto vivaldiano per soprano, archi e basso continuo conservato al di fuori dell’Italia. Ci è pervenuto attraverso due raccolte manoscritte, entrambe custodite a Londra: un set di parti staccate appartenente al Royal College of Music e una partitura conservata alla British Library. La struttura del mottetto è quella convenzionale: due arie, intercalate da un breve recitativo, e concluse con un brillante Alleluia. Lo stato incompleto delle fonti (la seconda delle quali fu evidentemente copiata dalla prima) è di un tipo piuttosto insolito. Nella sua forma attuale la partitura comprende una parte vocale, un basso strumentale e una parte di violino primo, tuttavia è evidente che in origine doveva esistere almeno una parte di mezzo (probabilmente due, in conformità con gli altri mottetti sopravvissuti di Vivaldi), poiché in tutte le circostanze, assai frequenti, in cui il basso è in pausa, la parte di primo violino continua come una linea «sopranina» piuttosto che come un basso armonico. Per la ricostruzione sono state aggiunte dal curatore delle parti di mezzo per un violino secondo e una viola, compito non particolarmente diffi cile, in quanto molti passaggi trovano delle precise corrispondenze in altre opere di Vivaldi.
Antonio Vivaldi. Carae rosae, respirate. Mottetto per soprano, archi e basso continuo, RV 624