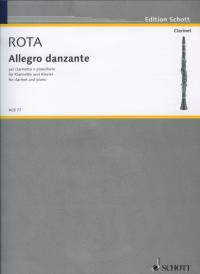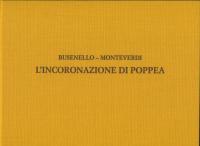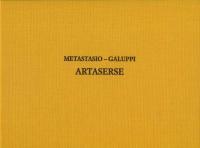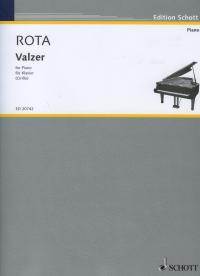Prefazione
Verso la fine dell’Ottocento, dopo il plurisecolare monopolio del melodramma, si assiste in Italia a un rinasimento dell’musica strumentale. Grazie a una generazione di compositori che traghetteranno la cu ltura musicale italiana dall’arretrato isolamento in cui era man mano caduta a un pieno inserimento nel consueto europeo, con una peculiarità di intendimenti e felicita di realizzazioni che hanno fatto parlare, come in passato, di scuola italiana o, almeno di maniera italiana di intendere la musica nella modernità, le cui ramificazioni e influssi continuato in certo modo ancor oggi.
Un saggio dell’inventiva e della verve di Rota si ha anche nel breve Allegro danzante scritto nel 1977 durante un soggiorno estivo a Fiuggi, foglio d’album tripartito in cui ritroviamo appieno la personalità dell’Autore e il suo infallibile senso dell’armonia e dei cromatismi.
Il brano è qui pubblicato per la prima volta e il manoscritto si trova presso l’archivio Rota della Fondazione Cini di Venezia.
Gabriele Rota