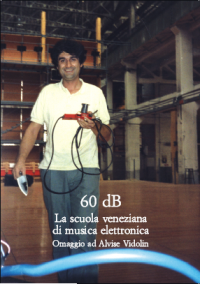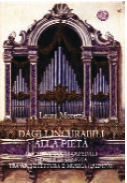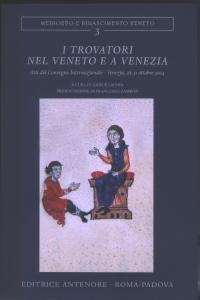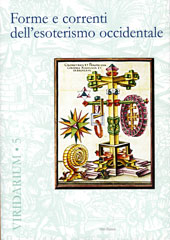Fra i quattro oratori a noi noti attribuibili a Vivaldi, Juditha triumphans è il solo a sopravvivere. Già riconosciuto come un capolavoro al tempo della riscoperta della musica inedita del musicista, negli anni venti del ’900, quest’oratorio, scritto per cinque solisti vocali, coro e un’orchestra comprendente numerosi strumenti obbligati poco usuali (mandolino, chalumeau, clarinetti, flauti dritti, organo, viola d’amore, un concerto di viole da gamba, etc), fu composto per le figlie di coro dell’Ospedale della Pietà a Venezia, dove fu eseguito nell’anno 1716. Il libretto, di Giacomo Cassetti, è in lingua latina (come si praticava abitualmente negli ospedali veneziani), e adotta la storia biblica di Juditha come allegoria della lotta militare di Venezia in quegli anni contro l’impero ottomano. Di particolare interesse è la caratterizzazione di Oloferne che, sebbene sia ufficialmente il personaggio ‘malvagio’ della trama, viene trattato, nel libretto e nella musica, con una simpatia inattesa. Juditha triumphans, che gli storici della musica citano spesso come esempio della tendenza ‘operatizzante’ all’interno dell’oratorio settecentesco, spicca per l’originalità e l’alta qualità della sua musica.
Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie – Sacrum Militare Oratorio, RV 644