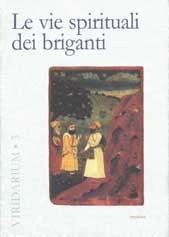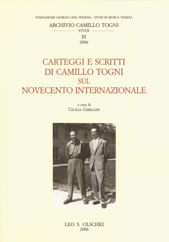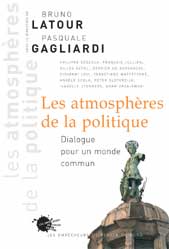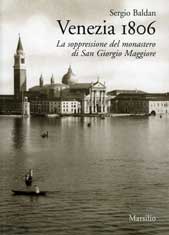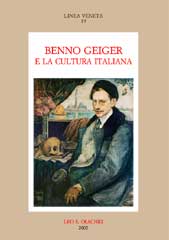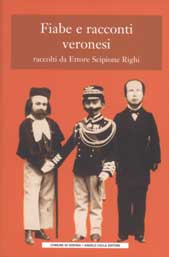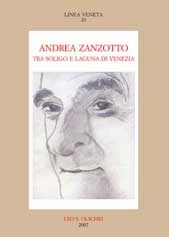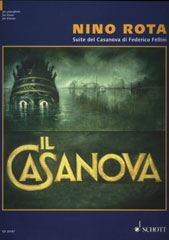Per quanto strano possa
sembrare, il lettore non specialista che abbia la curiosità di
conoscere le vicende di Atene tardoantica e bizantina deve ancora
rivolgersi alla celebre Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter di Ferdinand Gregorovius (1889), peraltro mai tradotta in lingua
italiana. Questo lavoro si propone dunque di colmare una lacuna negli
studî ateniesi, offrendo una sintesi completa per quel che concerne il
periodo tardoantico, durante il quale la polis ateniese fu sede delle
grandi scuole sofistiche, dove affluirono studenti da ogni parte
dell’Impero, e della famosa scuola neoplatonica, dove si elaborarono i
fondamenti del pensiero filosofico tardoantico e bizantino; in questa
stessa epoca, inoltre, la città-simbolo del paganesimo
ellenistico-romano è costretta a fare i conti con la nuova realtà del
cristianesimo in espansione, e ciò dà origine a interessanti fenomeni
sia sul piano più specificamente religioso e filosofico sia su quello
politico e sociale.
Il libro allarga lo sguardo anche sulle
posteriori vicende storiche e culturali di Atene, soffermandosi in
particolare sull’immagine della città nelle fonti tardoantiche e
bizantine.
INDICE
Prefazione
Introduzione
Capitolo I – La città dei sofisti: retorica e politica ad Atene fra II e IV secolo d.c.
Capitolo II – Tra Amfione e Achille: realtà e mitologia della difesa di Atene fra III e IV secolo
Capitolo III – «I giardini di Atene»: Giuliano imperatore e l’utopia ateniese
Capitolo IV – La città dei filosofi: filosofia e politica ad Atene da Plutarco a Damasco
Capitolo V – «Quid ergo Athenis et Hierosolymis?»: Pagani e cristiani ad Atene da san Paolo a Giustiniano
Appendice – Atene immaginaria: il mito di Atene nella letteratura bizantina tra agiografia, teosofia, e Mirabilia
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it