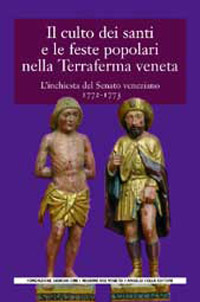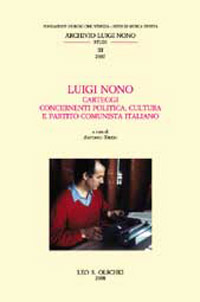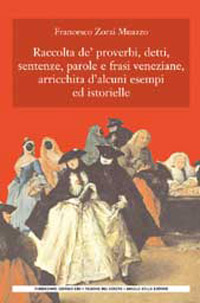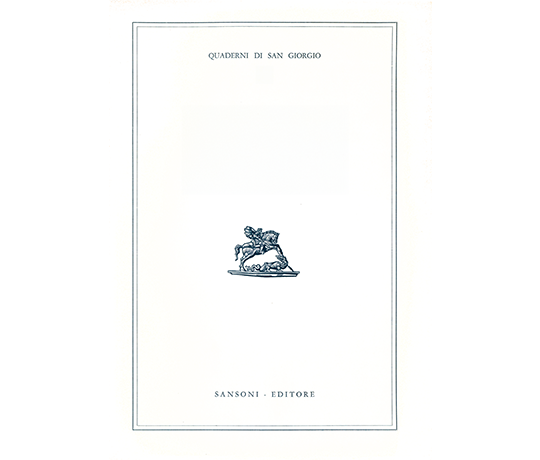Per poter procedere a una drastica limitazione dell’eccessivo numero di feste che costellavano il variegato calendario popolare e contadino onde ridurre il calo produttivo causato dalla sospensione dei lavori e dalle pratiche del malcostume connesse alle celebrazioni sfrenate e ai divertimenti, e in questo modo contrastare la concorrenza delle potenze vicine nelle attività agricole e commerciali, nel 1772 il Senato della Serenissima avvia un’inchiesta per sapere quali fossero le feste religiose celebrate in ogni parrocchia della Terraferma veneta oltre a quelle di precetto imposte dal calendario ufficiale della Chiesa. Le puntuali risposte fornite dai parroci ci permettono di conoscere il vasto florilegio del culto popolare dei santi, dai più vicini all’ortodossia ecclesiastica, come gli onnipresenti san Rocco e sant’Antonio Abate, san Sebastiano e san Marco, fino a quelli creati dall’immaginazione popolare, come il mitico san Defendente.
Ma le relazioni scritte inviate al Senato, conservate nella Biblioteca Marciana e ora per la prima volta trascritte e pubblicate da Simonetta Marin, danno conto anche della tipologia delle feste, votive e di devozione, delle loro origini note o supposte, e dei riti che le caratterizzavano, processioni, veglie, culto delle reliquie, preghiere, nonché degli eccessi superstiziosi e dei disordini sociali e morali che talvolta le accompagnavano. Ne esce un quadro vivido della religiosità popolare, delle consuetudini rurali e del folklore in tutto il Veneto, il Friuli e fino a Brescia e a Bergamo, mentre, come spiega l’illuminante saggio critico di Claudio Povolo premesso alla raccolta dei documenti, questi ultimi offrono materiali interessanti per considerazioni di più ampio interesse che riguardano anche l’antropologia culturale e perfino gli aspetti della giustizia penale collegata ai problemi morali. Nella prefazione di Antonio Niero, invece, è delineata la storia dei tentativi di riforma del culto dei santi e della riduzione delle feste religiose compiuti, con scarsi esiti, dai papi postridentini.
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it