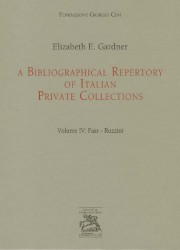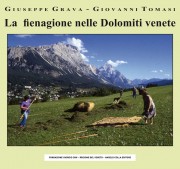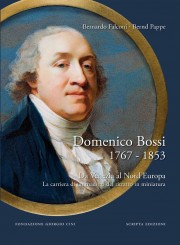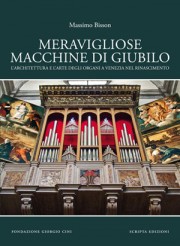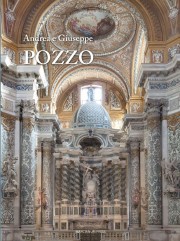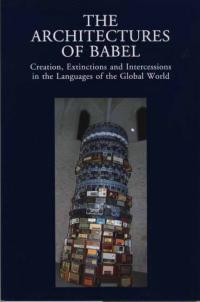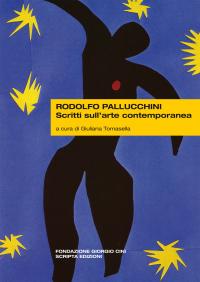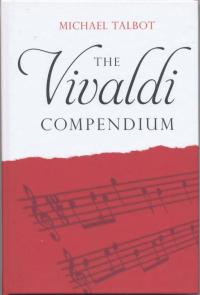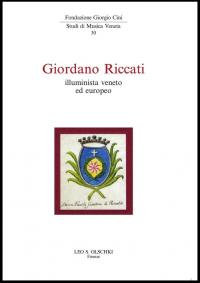A cura di Chiara Ceschi, con l’assistenza di Daniele D’Anza e Matteo Gardonio
Elizabeth E. Gardner, curator nel “Dipartimento di pittura europea” del Metropolitan Museum di New York, aveva iniziato sin dal 1946 a raccogliere notizie biografiche e bibliografiche sui collezionisti italiani, ponendo particolare attenzione alla storia e alla provenienza dei dipinti di proprietà del Metropolitan. L’archivio che si andava formando – tuttora unico nel suo genere e costituito nel 1973 da quasi 10.000 voci relative alle
collezioni italiane – si rivelò di fondamentale importanza per le ricerche confluite nella serie dei cataloghi a stampa del Museo.
L’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini, cui l’autrice ha affidato le schede originali manoscritte con l’intento di creare un nuovo strumento di ricerca per gli studiosi del collezionismo italiano, dopo la scomparsa di Elizabeth E. Gardner ha fatto proprio il progetto e si è fatto promotore della pubblicazione a stampa. Le voci sono state aggiornate ed organizzate in forma di dizionario bio-bibliografico, formando così un repertorio dei collezionisti di opere d’arte presenti in Italia dal Quattrocento ai giorni nostri come venivano registrati dalle fonti letterarie principali, nei documenti d’archivio, nei cataloghi di mostre, di musei e di vendite. Ogni volume è corredato dalla Bibliografia e dagli Indici degli artisti e dei personaggi citati.