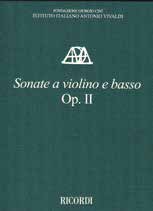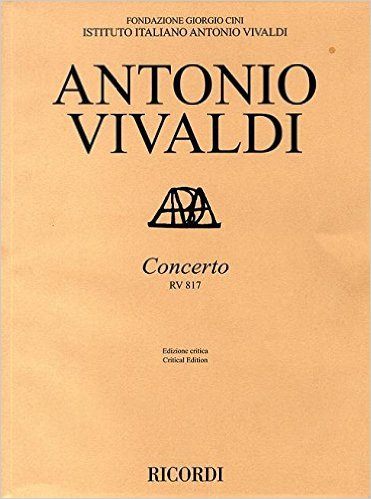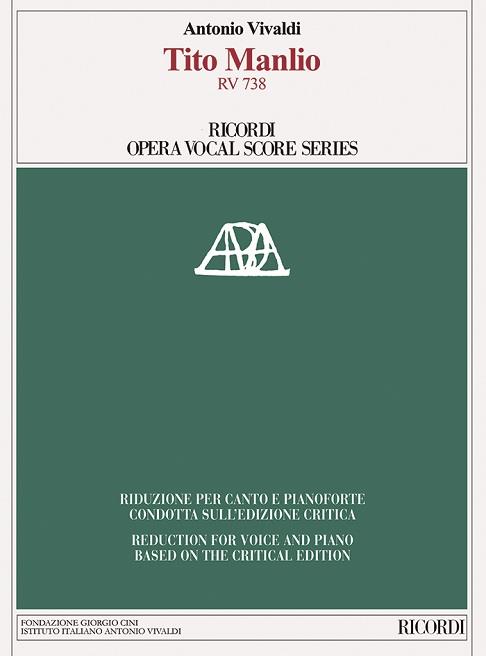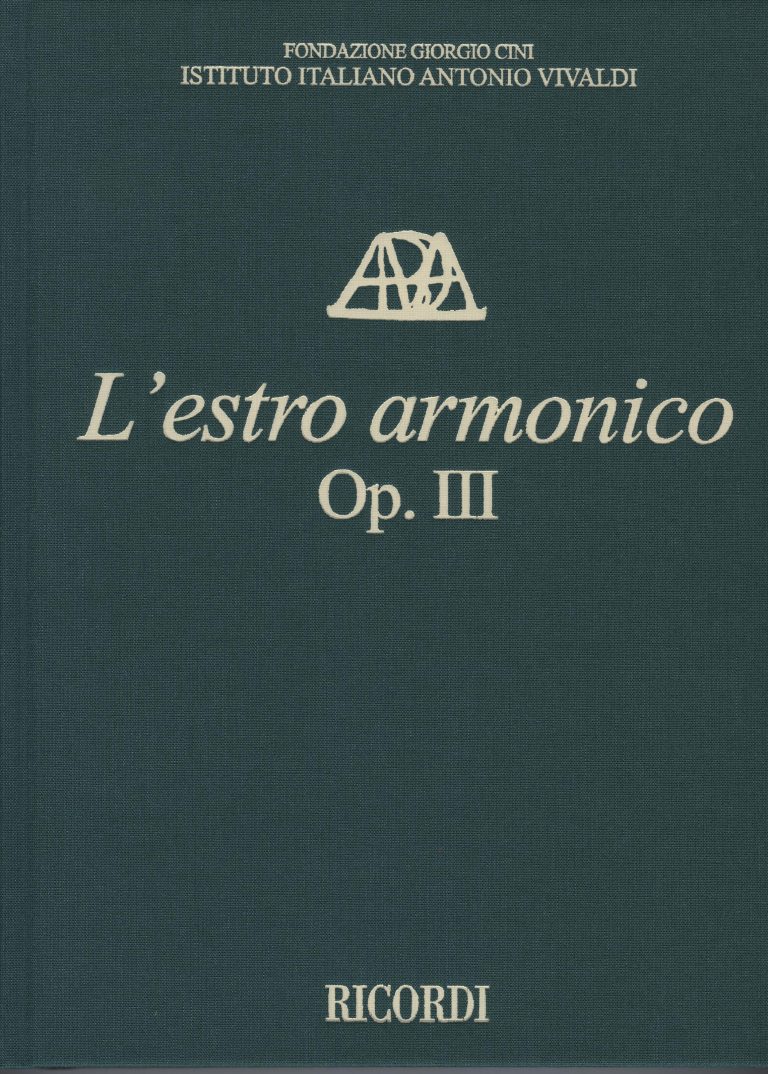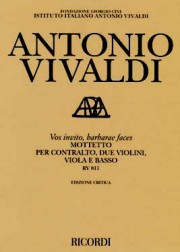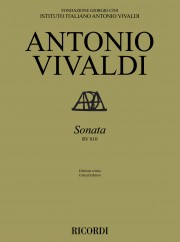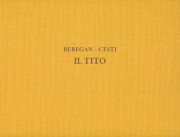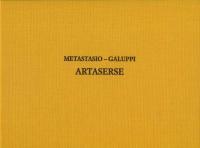Antonio Vivaldi
12 sonate per violino e basso, Opera II
Edizione critica a cura di Federico Maria Sardelli
“Edizione critica delle Opere di Antonio Vivaldi”
Ricordi, Milano, 2014
La seconda raccolta a stampa di Vivaldi e fondamentale per capire il salto dall’artigianato provinciale alla fama europea spiccato dal compositore sul finire della prima decade del secolo XVIII. L’edizione affronta e scioglie i nodi della datazione esatta, della committenza e del contesto veneziano. Dall’analisi delle diverse tecniche di stampa –a caratteri mobili e calcografica –e dal confronto delle fonti viene ricostruito il contesto in cui l’opera vide la luce e quali furono i suoi reali aspetti innovativi; l’edizione fa il punto sulla ricezione dell’opera, elencando il vasto stuolo di compositori che dall’Opera II attinsero o rubarono idee e soluzioni musicali, testimonianza di una diffusione e un’influenza assai profonda. L’Opera II di Vivaldi, a lungo e ingiustamente trascurata dai critici e dagli esecutori, può considerarsi il manifesto del nuovo linguaggio musicale vivaldiano applicato alla musica da camera, preparato quasi contemporaneamente a quell’altro grande manifesto del nuovo concerto solistico che sarebbe uscito di li a poco con la raccolta de L’estro armonico.