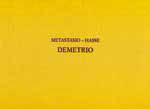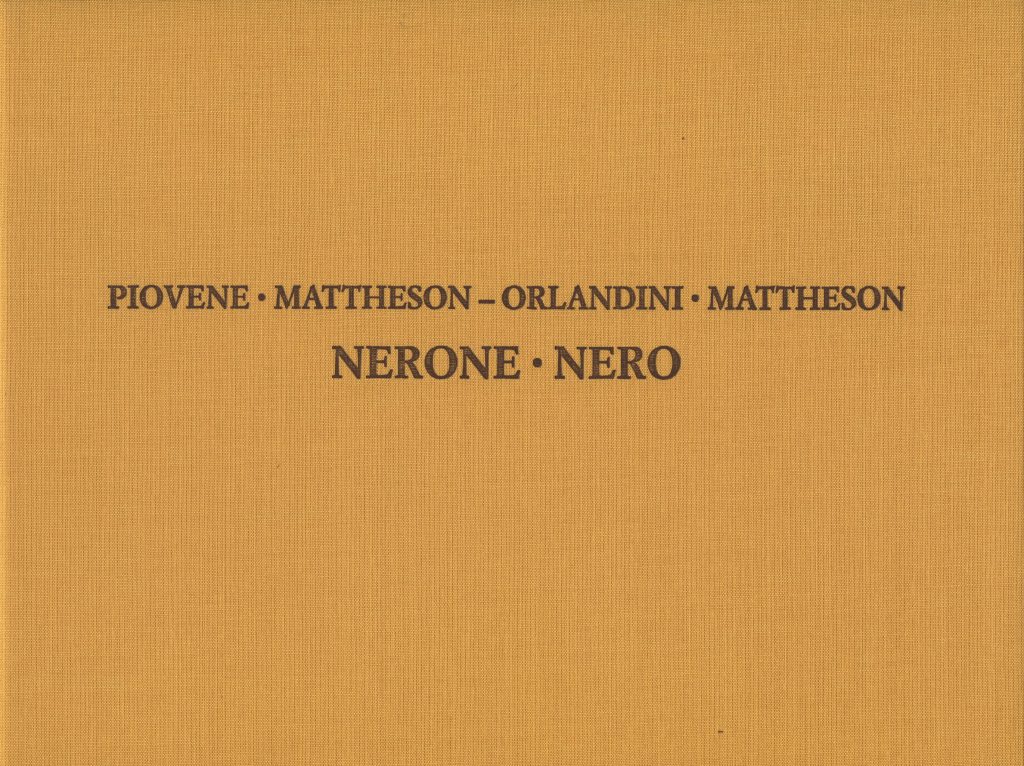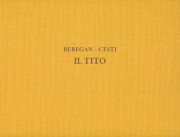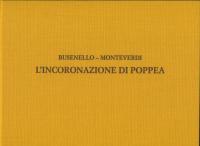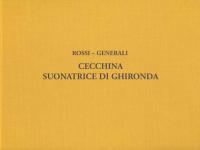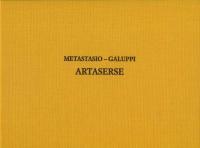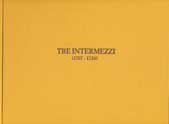La finta pazza
Libretto di Giulio Strozzi Musica di Francesco Sacrati Edizione in facsimile della partitura ed edizione critica del libretto a cura di Nicola Usula; saggi introduttivi di Lorenzo Bianconi, Wolfgang Osthoff e Nicola Usula.
«Drammaturgia musicale veneta», 1
Ricordi, Milano, 2018
Nel Fondo Musiche dell’Archivio dei principi Borromeo sull’Isola Bella (Stresa) si conserva quella che a oggi risulta essere la più antica partitura superstite di un’opera allestita a Venezia in un teatro a pagamento: La finta pazza di Giulio Strozzi con le musiche di Francesco Sacrati, messa in scena nel 1641 per l’inaugurazione del Teatro Novissimo, l’ultima fatica dell’acclamato architetto e scenografo Giacomo Torelli. Dopo anni d’attesa il facsimile di questa partitura vede la luce in un’accurata edizione corredata di materiali iconografici, del libretto dell’opera e di tre saggi introduttivi a cura di Lorenzo Bianconi, Wolfgang Osthoff e Nicola Usula. Nel primo Lorenzo Bianconi chiarisce le circostanze del ritrovamento della partitura sull’Isola Bella nel 1984 e propone una carrellata degli studi che si sono avvicendati dagli anni settanta del Novecento in avanti riguardo a quest’opera. Di seguito Wolfgang Osthoff avanza una riflessione sulla trasposizione in musica della pazzia nella Finta pazza di Sacrati e in altre opere del Seicento veneziano; mentre nel terzo saggio Nicola Usula, assieme a uno studio del fondo operistico secentesco conservato sull’Isola, propone una dettagliata analisi codicologica del manoscritto e ne individua le coordinate cronologiche e geografiche di confezionamento. Il volume contiene infine l’edizione critica della prima versione itinerante del libretto della Finta pazza (legata all’allestimento piacentino del 1644), e la riproduzione delle cinque incisioni a stampa con le scenografie che Giacomo Torelli realizzò per la ripresa parigina del 1645.