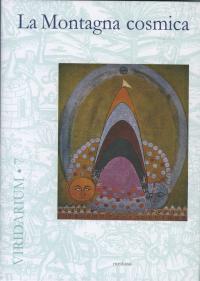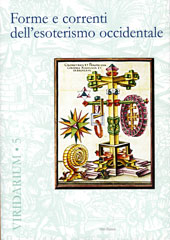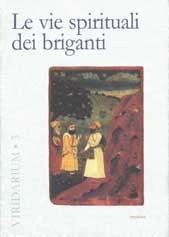“Queste cose non le ascolto con le orecchie del corpo e neppure nei pensieri del mio cuore, e non le percepisco per interazione dei miei cinque sensi, ma unicamente all’interno della mia anima, con gli occhi aperti, per cui nelle mie visioni non subisco mai il venir meno dell’estasi: le vedo in stato di veglia, di giorno e di notte”.
Così descriveva le sue visioni una delle più grandi mistiche medievali, Hildegart von Bingen, in una famosa lettera a Ghiberto di Gembloux. Non solo nel medioevo cristiano ma in quasi tutte le grandi culture e tradizioni religiose è presente l’idea di un “occhio interiore” o “occhio del cuore” con il quale è possibile percepire le realtà spirituali e divine, così come con gli occhi normali si percepiscono le realtà esterne. Tale idea può tuttavia generare dei paradossi che sono al centro di molte riflessioni intorno alle esperienze visionarie. Se l’oggetto della “visione” trascende infatti per definizione il piano delle realtà materiali e visibili, come è possibile conoscerlo attraverso delle immagini? E se il suo scopo è quello di raggiungere e di esperire in qualche modo ciò che sta oltre qualsiasi forma e qualsiasi rappresentazione, di “denudarsi” di ogni immagine visibile, come è possibile “vederlo”, sia pure con uno sguardo interiore? Il problema del rapporto fra “visibilità” e “invisibilità” riaffiora continuamente ed è variamente affrontato e risolto nella tradizione visionaria occidentale, come in quelle di altre civiltà, per presentarsi con inaspettata radicalità anche in certe espressioni del pensiero e dell’arte contemporanea.
Il presente volume affronta queste tematiche attraverso otto contributi dedicati ad autori e a opere di epoche e civiltà diverse. Cinque saggi provengono dal Gruppo di Ricerca della “Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas” dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona. Il Gruppo è diretto da due dei massimi specialisti attuali di mistica, Amador Vega e Victoria Cirlot, che qui presentano due lavori dedicati all’estetica contemporanea della visione: quello di Vega riguarda la “irruzione dell’invisibilità” nella pittura del grande artista americano Mark Rothko, e analizza in particolare la sua straordinaria Cappella nel campus della St. Thomas University di Houston; quello di Victoria Cirlot esamina il rapporto fra ricerca psicologica e tradizione visionaria nel “Libro Rosso” o “Liber novus” di Carl Gustav Jung, di cui è stata recentemente pubblicata – con traduzione in diverse lingue – la prima riproduzione fotografica completa. Gli altri tre interventi sono opera di giovani e brillanti componenti del Gruppo di Ricerca, che ci riportano alle figure di alcuni importanti mistici del medioevo e dei secoli successivi: Sergi Sancho studia l’immagine della donna-albero in una visione di Marguerite d’Oingt; Pablo García Acosta il complesso e paradossale rapporto fra visibilità e negazione dell’immagine nel Mirouer des simples ames di Marguerite Porete; Anna Serra Zamora la visione dell’interiorità nell’opera del grande mistico spagnolo San Juan de la Cruz.
Due ampi saggi sono dedicati a tradizioni diverse da quella occidentale e cristiana. Carlo Saccone, insigne islamista dell’Università di Bologna e assiduo collaboratore di “Viridarium”, esamina il caso particolare delle visioni mistiche (fotismi e testimoni divini, fra cui quello del bellissimo efebo) ne Gli schiudimenti della Bellezza e i profumi della Maestà di Najm al-din Kubrà, sufi orientale del XIII secolo. Di Moshe Idel, il più grande specialista mondiale della Qabbalah, si presenta qui la prima traduzione italiana di un fondamentale studio sul linguaggio dell’esperienza estatica nella mistica ebraica. Completa il volume – corredato da un ampio apparato di immagini – un secondo lavoro dedicato al “Libro Rosso” di Jung, quello del condirettore di “Viridarium” Alessandro Grossato, che ne esamina i rapporti con i modelli orientali dello yantra e del mandala. Nel suo complesso esso costituisce così una sorta di iniziazione, attraverso “stazioni” o momenti decisivi, a un tema cruciale sia della storia delle religioni che dell’estetica.