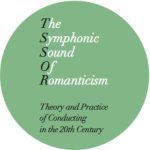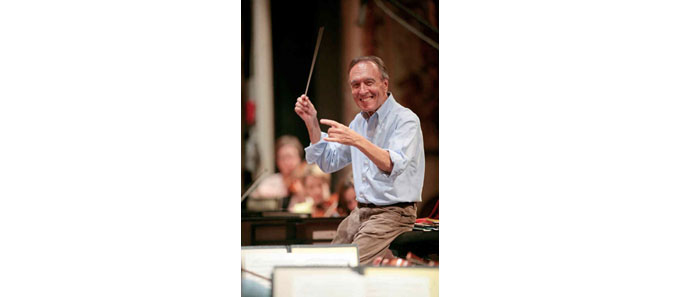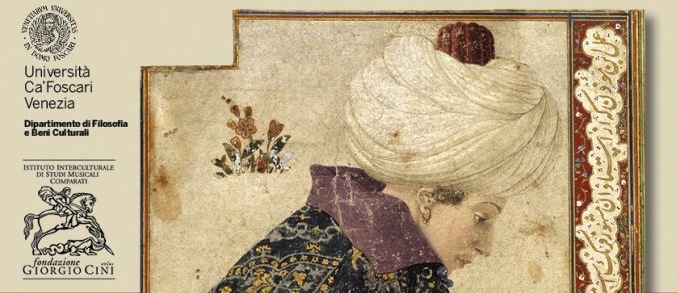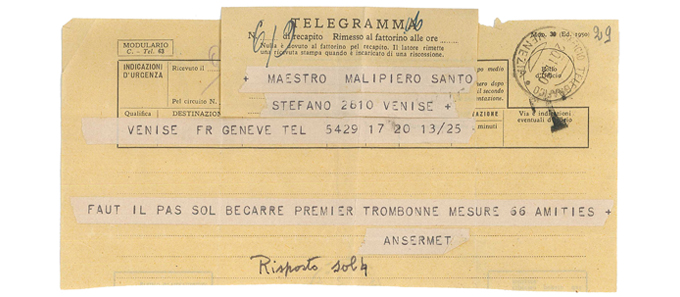L’accesso a cibo e acqua sono considerati diritti universali dalla Carta dei Diritti Umani della Nazioni Unite. Eppure oltre un miliardo di persone sulla Terra non ha accesso ad acqua pulita e soffre di denutrizione. La scarsità di cibo è la causa della maggior parte delle morti al mondo per malattia; la lotta per l’approvvigionamento a fonti di acqua pulita è una delle maggiori cause di conflitti armati. Di contro, le nazioni ricche del pianeta, che rappresentano una piccola parte dell’umanità, si trovano ad affrontare l’altro lato della medaglia della malnutrizione: l’eccesso di cibo e lo sviluppo dell’obesità, diventata una vera e propria epidemia con gravi conseguenze sulla salute. Con l’aumentare della popolazione mondiale, la risoluzione di questi problemi e una più equilibrata ridistribuzione delle risorse alimentari non è solo un imperativo morale, ma rappresenta l’unica strada per uno sviluppo sostenibile e per la sicurezza a livello
mondiale. La scienza e la tecnologia, se utilizzate con saggezza, possono apportare contributi essenziali alla via della risoluzione, guidando l’implementazione di soluzioni per assicurare a tutti sufficienti cibo e acqua pulita.
Questi i temi della decima edizione di The Future of Science – Conferenza Mondiale promossa da Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Giorgio Cini e Fondazione Tronchetti Provera – che verranno discussi da eccellenti relatori, competenti in diverse aree: cambiamenti climatici e desertificazione, agricoltura sostenibile, aumento esponenziale nel consumo di cibi di origine animale e patologie correlate (ad esempio diabete, obesità e malattie cardiovascolari), sicurezza e salute alimentare, ingegneria genetica e piante, implicazioni economiche, etiche e politiche.