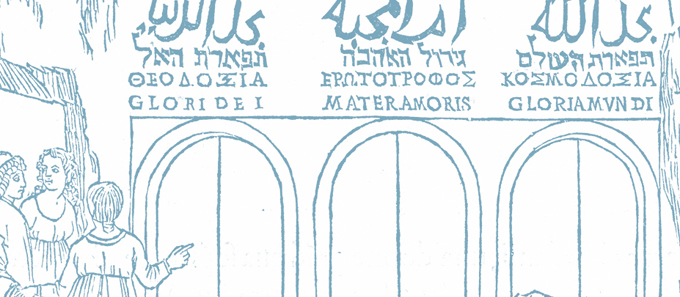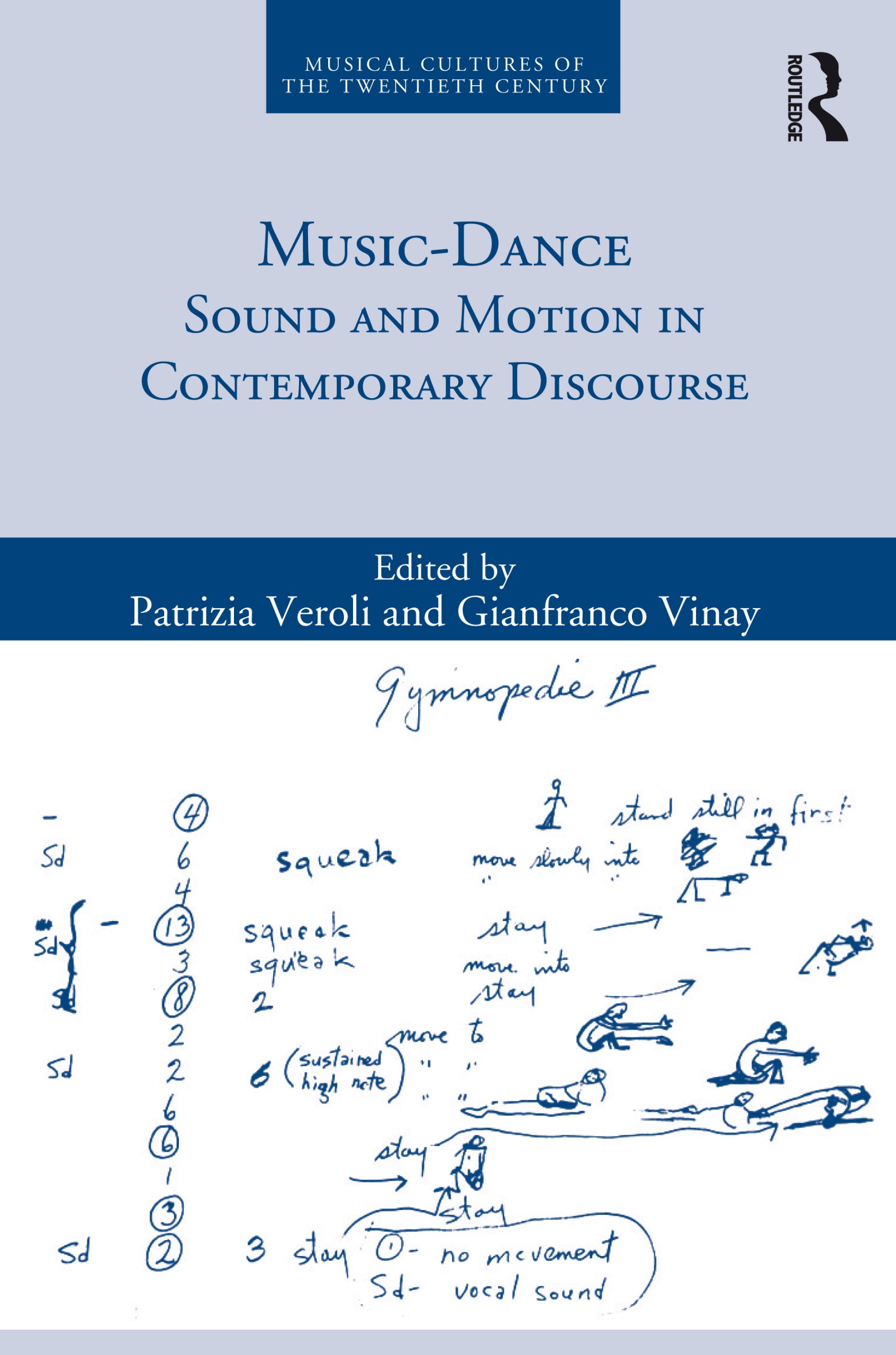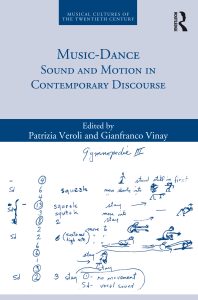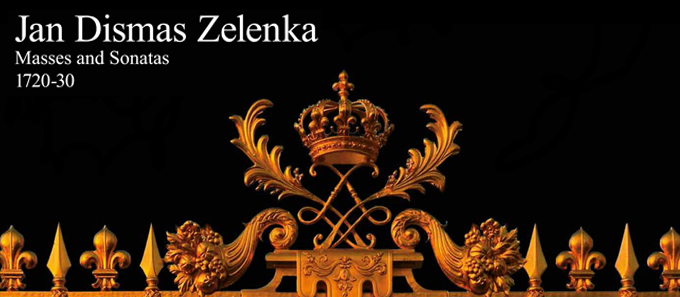Accademia Vivaldi 2018
Incontri di perfezionamento sulla prassi esecutiva della musica di Antonio Vivaldi
L’Istituto Italiano Antonio Vivaldi organizza otto incontri di approfondimento sulla prassi esecutiva delle composizioni di Antonio Vivaldi, dedicato a cantanti e strumentisti.
Ogni incontro si svolgerà presso la Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia, e avrà una durata di tre intere giornate, dalle ore 14 del primo giorno (mercoledì) alle ore 13 del quarto giorno (sabato).
I docenti sono Gemma Bertagnolli (canto), Giorgio Fava (violino) e Walter Vestidello (violoncello). Maestro accompagnatore al cembalo: Antonio Frigé.
14-17 Febbraio; 14-17 Marzo; 18-21 Aprile; 16-19 Maggio; 6-9 Giugno; 24-27 Ottobre; 14-17 Novembre.
Termine per la presentazione delle domande: 5 febbraio; 12 febbraio; 12 marzo; 16 aprile; 7 maggio; 24 settembre; 15 ottobre.
Dopo il successo dell’Accademia Vivaldi che ha avuto luogo nel luglio del 2017, l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi organizza quest’anno una nuova Accademia articolata in otto incontri di approfondimento sulla prassi esecutiva delle composizioni del Prete Rosso. Gli incontri, della durata di tre intere giornate ciascuno, sono rivolti a giovani musicisti e cantanti, e si svolgeranno presso la Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore di Venezia.
Quattro incontri sono tenuti dalla soprano Gemma Bertagnolli e si focalizzeranno sul repertorio vocale sacro, sulle serenate e le cantate da camera e sui drammi per musica.
Due incontri, tenuti dal violinista Giorgio Fava, sono dedicati al repertorio violinistico (le sonate a uno e a due violini e i concerti per violino) e altri due incontri affronteranno il repertorio violoncellistico (le sonate e i concerti), a cura del violoncellista Walter Vestidello.
A tutti gli incontri dell’Accademia prenderà parte il clavicembalista Antonio Frigé – collaboratore dell’Istituto Vivaldi per la preparazione delle edizioni critiche – che accompagnerà gli allievi dei corsi.
Oltre all’aspetto pratico-esecutivo i partecipanti ai seminari potranno approfondire – confrontandosi con i musicologi che collaborano con l’Istituto proseguendo lo scambio fra musicisti e musicologi inaugurato nella precedente edizione dell’Accademia – i vari aspetti teorici riguardanti le composizioni e i contesti vivaldiani consultando le riproduzioni degli originali e le diverse pubblicazioni conservate presso l’archivio e la biblioteca dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi.
Al termine dell’incontro di novembre sarà organizzato un concerto finale.
Gemma Bertagnolli
Ha iniziato giovanissima una carriera che l’ha portata in breve a cantare nei principali teatri e festival italiani ed esteri. E’ considerata una delle interpreti di riferimento per la musica barocca italiana. Attualmente è docente di canto barocco presso il Dipartimento di musica antica del Conservatorio di Vicenza, presso la HFK di Brema e presso l’Accademia internazionale di Kusatsu, Giappone.
Giorgio Fava
Giorgio Fava è cresciuto musicalmente nella propria città, Treviso, sotto la guida di Antonio e Giuliano Carmignola, perfezionandosi in seguito con il maestro Corrado Romano di Ginevra. Sempre nella città svizzera, presso il Centre de Musique Ançienne, si è diplomato con lode nel 1985 in violino barocco nella classe di Chiara Banchini.
Dal 1983 si dedica in qualità di primo violino all’attività dei “Sonatori de la Gioiosa Marca”, gruppo internazionalmente riconosciuto e che ha conquistato un ruolo di riferimento nell’interpretazione della musica veneziana del XVII e XVIII secolo.
Ha partecipato a numerose registrazioni per le più importanti case discografiche (Erato, Warner Classics, Decca, Divox, Opus 111, Arcana, RCA e DHM/Sony) ed emittenti radiofoniche europee.
All’attività concertistica e di ricerca, affianca da sempre quella didattica. Docente dal 1981 prima al Conservatorio di Venezia poi di Castelfranco Veneto, è stato Professore di violino barocco all’Hochschule für Musik di Trossingen in Germania dal 1994 al 1997.
Nell’ambito del Premio Internazionale del Disco Antonio Vivaldi, istituito dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, ha ricevuto nel 2001 il premio speciale della giuria.
Walter Vestidello
Walter Vestidello ha studiato con Adriano Vendramelli al Conservatorio di Musica ‘B. Marcello’ di Venezia.
Giovanissimo, per alcuni anni ha coperto il posto di ‘Primo violoncello’ dell’Orchestra Filarmonia Veneta; ora collabora nello stesso ruolo con l’Orchestra della Fenice e con l’orchestra Filarmonica del Teatro di Venezia.
Nel 1983 ha fondato, con altri musicisti trevigiani, i ‘Sonatori de la Gioiosa Marca’, ensemble che interpreta musiche del periodo barocco-classico seguendo le regole della prassi originale ed esibendosi da più di trent’anni in numerose manifestazioni musicali in tutta Europa avvalendosi della collaborazione di solisti di fama mondiale.
Dal 2007 al 2012 ha collaborato stabilmente come ‘Primo violoncello’ con l’Orchestra Mozart (fondata e diretta da Claudio Abbado) prendendo parte ai concerti cameristici dei solisti dell’orchestra, proposta fatta dal M° Abbado stesso.
Ha tenuto corsi di violoncello barocco per Asolo Musica, al Conservatorio di Vicenza, alla Fondazione ‘G. Cini’ di Venezia, a Valdagno e Recoaro (Vicenza), Chioggia, San Vito al Tagliamento. Insegna violoncello barocco/classico al Conservatorio ‘J. Tomadini’ di Udine e, nel Biennio accademico superiore, al Conservatorio di Castelfranco V. dove per quasi dieci anni ha coordinato l’attività strumentale di musica antica.
Ha curato per alcuni anni la preparazione della fila dei violoncelli dell’OGI (Orchestra Giovanile Italiana) e ha partecipato inoltre alle attività dell’Accademia Filarmonica di Bologna in qualità di preparatore per il violoncello e la Musica da camera.
Ha collaborato a lungo con la RADIO della Svizzera italiana, ha registrato per Rai3, per la Radio austriaca, la WDR (Germania) e la Deutchland Rundfunk di Colonia e, per quanto riguarda le registrazioni discografiche, con la ‘Deutsche Harmonia Mundi’, Opus 111-WDR, Divox Antiqua, RCA, Virgin, Warner Classics (‘Concerti per violoncello’ di Vivaldi in qualità di solista).
E’ titolare di una cattedra di violoncello presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV).
Antonio Frigé
Nato a Milano Antonio Frigé si è diplomato in Organo e Composizione Organistica ed in Clavicembalo presso il Conservatorio “G.Verdi” della sua città, ha intrapreso un’intensa attività concertistica che lo ha portato a suonare, per le più prestigiose Società Concertistiche, in tutta Europa e negli U.S.A.
Particolarmente appassionato alla letteratura del sei-settecento eseguita su strumenti “storici”, ha registrato diversi Cd sia come solista sia in gruppi strumentali.
Dal 1982 suona in Duo con Gabriele Cassone e, nel 1989, ha fondato l’Ensemble “Pian & Forte”.
Attualmente è docente di Basso continuo e Musica d’Insieme all’Istituto di Musica Antica presso la Scuola Civica di Musica Claudio Abbado di Milano e organista della Basilica di S. Simpliciano, a Milano.
Calendario degli incontri
Dal 14 al 17 Febbraio: La musica vocale sacra (Gemma Bertagnolli)
Dal 14 al 17 Marzo: La musica vocale profana (le cantate e le serenate) (Gemma Bertagnolli)
Dal 18 al 21 Aprile: Le sonate per uno e due violini (Giorgio Fava)
Dal 16 al 19 Maggio: I drammi per musica I (Gemma Bertagnolli)
Dal 6 al 9 Giugno: Le sonate per violoncello (Walter Vestidello)
Dal 24 al 27 Ottobre: I drammi per musica II (Gemma Bertagnolli)
Dal 14 al 17 Novembre: I concerti per violoncello (Walter Vestidello) e I concerti per violino (Giorgio Fava)
Per ogni incontro saranno ammessi, a insindacabile giudizio della commissione, non più di sette allievi effettivi.
L’Istituto Italiano Antonio Vivaldi metterà a disposizione borse di studio, che copriranno le spese della frequenza, per tutti gli allievi ammessi.
Gli allievi potranno inoltre soggiornare sull’Isola di San Giorgio Maggiore, presso la Residenza del Centro Internazionale di Studi della Civiltà italiana Vittore Branca, in camera singola al prezzo di 55 euro a notte o in camera doppia al prezzo di 85 euro a notte.
I candidati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]:
- curriculum vitae dettagliato
- copia di un documento d’identità
- link a una registrazione video dell’esecuzione di due brani musicali di Antonio Vivaldi o altro autore del periodo.
Saranno ammessi ai corsi singoli allievi o formazioni già precostituite (1 o 2 violini + basso continuo).
Al termine di ogni incontro sarà rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza.
Gli incontri sono aperti anche ad allievi uditori, su richiesta e in seguito ad approvazione.