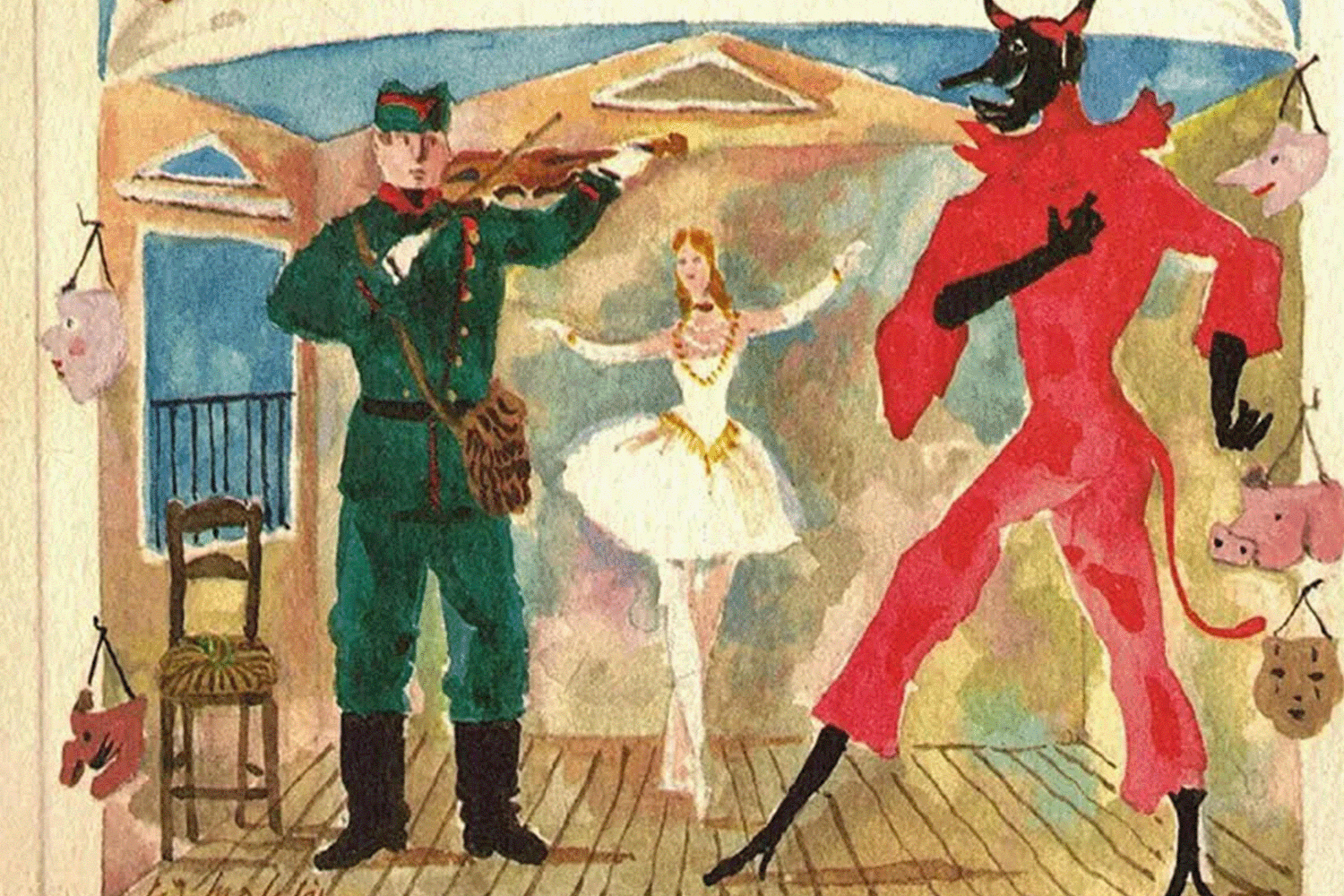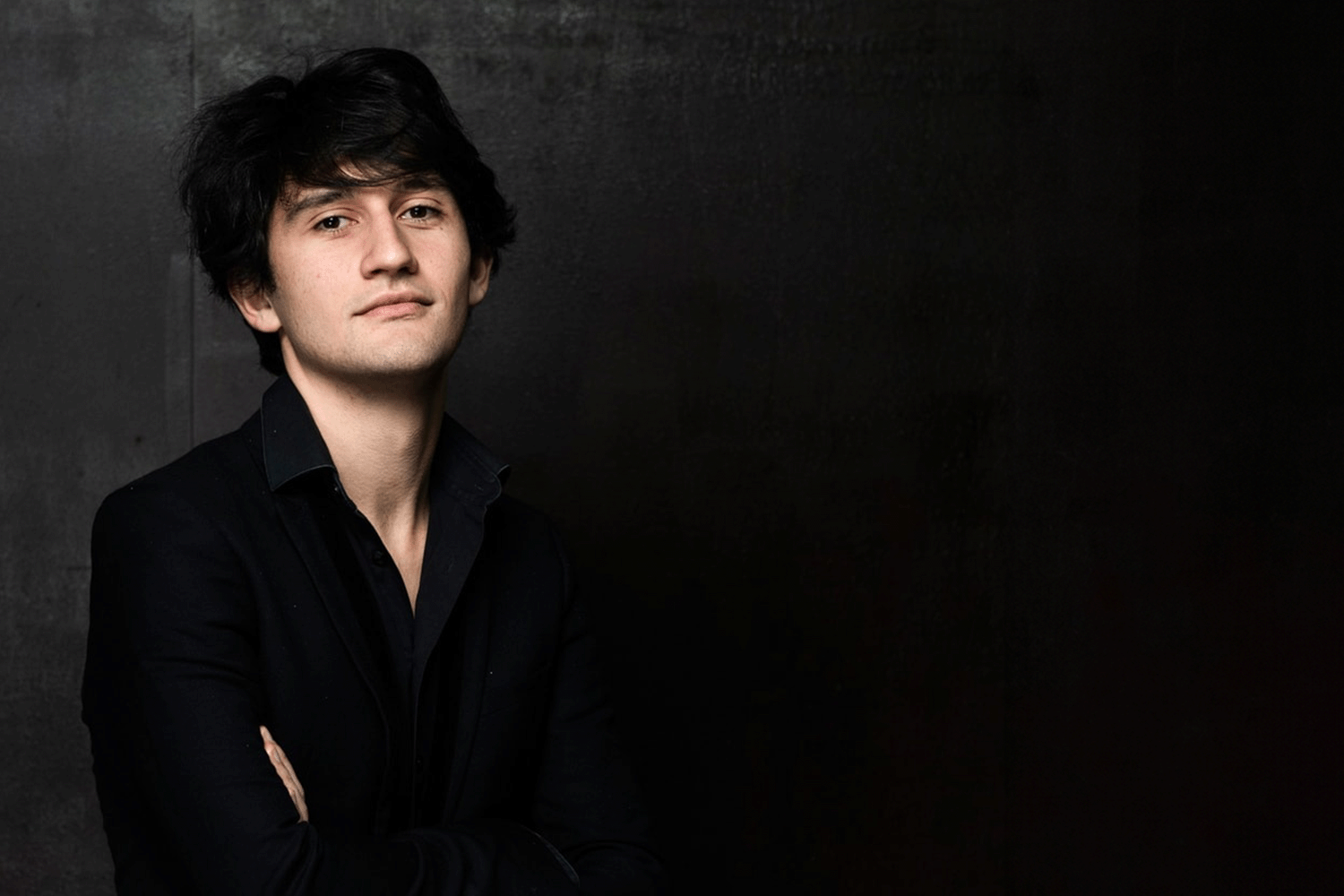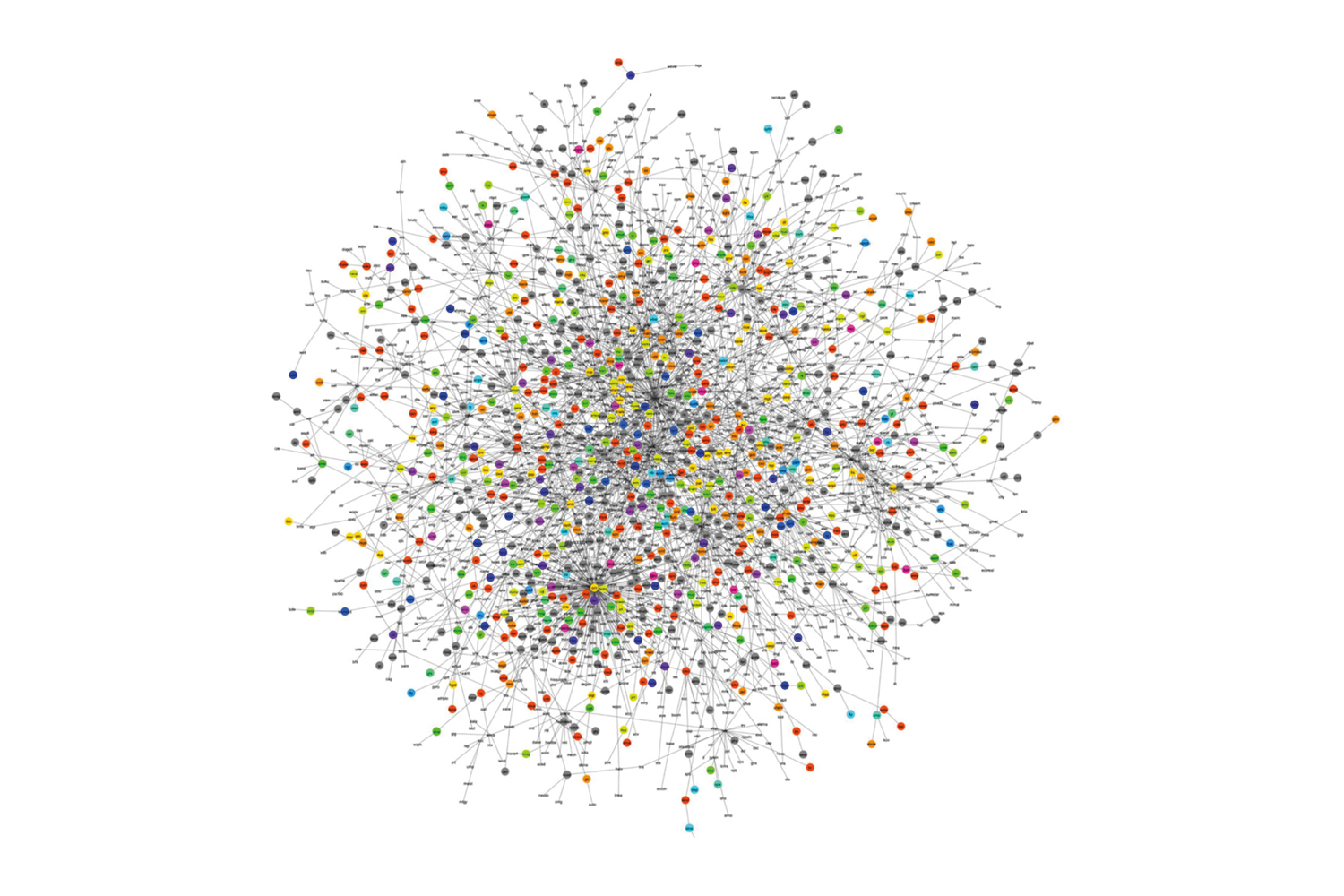Il simposio Transcendence in the Small Gestures of Life: Attention and Care for Nature and Humans in Religious Traditions esplora come le tecniche spirituali risvegliano la cura e l’attenzione verso il mondo naturale, gli altri esseri umani e la creazione.
Esperienze come le cerimonie sama sufi, l’uso del profumo nelle cerimonie funebri, e la cura di piante e animali sono esempi di come la spiritualità si esprima attraverso piccoli gesti che connettono alla trascendenza. Il simposio approfondisce anche come questi approcci spirituali influenzino lo studio delle religioni e le sfide contemporanee, in particolare la crisi ecologica globale.
L’evento è co-organizzato dal Centro di Studi Comparati sulle Civiltà e le Spiritualità (Fondazione Giorgio Cini) insieme all’Muslim Worlds Network of the European Association of Social Anthropologists (EASA) e al Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa) del dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona.
programma
9:30 – 10:00 | Welcome Greetings
- Francesco Piraino (Fondazione Giorgio Cini)
- Lili Di Puppo (FAU Erlangen-Nürnberg / KU Leuven)
- Fabio Vicini (University of Verona)
10:00 – 11:00 | Panel: Disarticulating Transcendence in the Everyday
- Paolo Sartori (Austrian Academy of Sciences, Vienna)
Historicising The Religion of the Inarticulate: The Spirituality of Labour in Socialist Uzbekistan
- Burcu Kalpaklıoğlu (University of Amsterdam)
Women’s Sense of their Hak, Divine Justice, and Economies of Divorce in Istanbul
Chair: Francesco Piraino (Fondazione Giorgio Cini)
11:00 – 11:30 | Coffee Break
11:30 – 12:30 | Panel: Everyday Care and the Sacred
- Mahiye Seçil Daǧtas (University of Waterloo / Balsillie School of International Affairs)
The Afterlives of Catastrophe: The Everyday Rhythms of the Sacred in Post-Earthquake Antakya
- Stefan Williamson Fa (University of Cambridge)
Food Encounters: The “Throwntogetherness” of Food, Faith, and Care in London
Chair: Fabio Vicini (University of Verona)
14:30 – 15:30 | Panel: Experiencing Subtle Forms of Transcendence
- Maria Louw (Aarhus University)
- Paige Scanlon (Harvard Divinity School)
Clapping Toward Clarity: How Nuns Use Tibetan Buddhist Debate as a Practice of Care
Chair: Lili Di Puppo (FAU Erlangen-Nürnberg, KU Leuven)
10:00 – 11:00 | Panel: Nature, Body, and Transcendence
- Roshan Iqbal (Agnes Scott College)
- Alba Siguero Lizano (Complutense University of Madrid)
From Being in Nature to Being Nature: The Sensory Dimension of Eco-Spiritual Political Ontologies
Chair: Lili Di Puppo (FAU Erlangen-Nürnberg / KU Leuven)
11:00 – 11:30 | Coffee Break
11:30 – 12:30 | Panel: Transcendence and Beauty in Pilgrimage
- Kholoud Al-Ajarma (University of Edinburgh)
Pilgrimage as Ecological Awakening: Islamic Ethics of Care during and after the Hajj
- Khando Langri (Stanford University)
Circumambulating Exile: Beauty, Care and Adornment in Tibetan Refugee Daily Practices of Kora
Chair: Fabio Vicini (University of Verona)
14:30 – 16:00 | Plenary
La conferenza si terrà in lingua inglese.