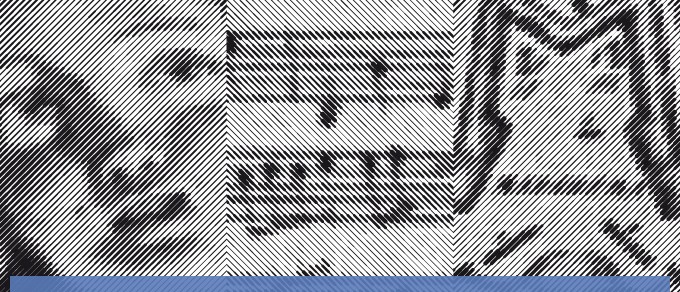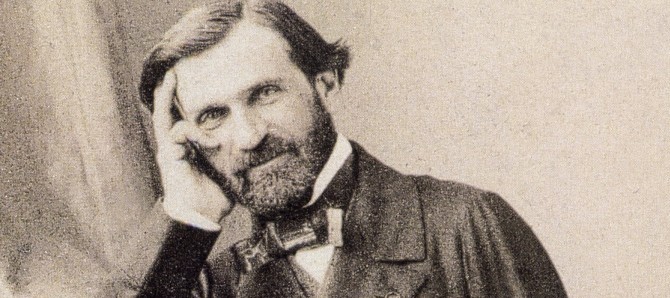Arangetram
Il 10 luglio alle ore 19, l’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Giorgio Cini, organizza un particolare spettacolo di danza indiana bharata natyam.
Si tratta dell’Arangetram, debutto, di Moritz Zavan Stoeckle, giovane danzatore veneziano, presentato al pubblico dal famoso coreografo e ballerino Mavin Khoo.
L’Arangetram, debutto di una danzatrice o danzatore di bharata natyam, viene celebrato solo a conclusione di un lungo ciclo di studi che riguardano la conoscenza dell’arte della danza, ma non solo, anche del senso estetico, delle buone maniere, della grammatica, della parola, della raffinatezza tipiche dell’aspetto “lasya” della danza bharata natyam. Il termine Arangetram infatti deriva da Arangam, che significa palcoscenico, ed etram che significa raggiungere o scalare, e richiama proprio la cerimonia di debutto durante la quale l’artista viene presentato al pubblico dal suo Guru, il maestro.
Sul palcoscenico Moritz Zavan Stoeckle sarà accompagnato da Pushkala Gopal (voce), Mavin Khoo (nattuvangam), Bhavani Shankar (mridangam) e Kartik Raghunathan (violino).
Il pubblico è invitato a partecipare anche alla cerimonia rituale che precederà lo spettacolo alle ore 18.45.
Moritz Zavan Stoeckle
Inizia a praticare la danza classica indiana Bharata Natyam all’età di dieci anni presso la Fondazione Giorgio Cini, Venezia, con l’insegnante Savitri Nair della Kalakshetra Foundation (Chennai) di cui segue gli stages fino al 2001. A Londra prosegue lo studio con il danzatore Mavin Khoo, allievo di A.K. Lakshman, con Vena Ramphal e Anusha Subrahmanyam. Nel 2004 lavora come ballerino al Teatro La Fenice di Venezia. Nel 2005 si trasferisce a Siena per studiare con l’insegnante Maresa Moglia dell’Associazione Natana Vedica-Est West Performing Arts. Dal 2005 si reca regolarmente in India a Chennai, dove studia con i maestri A. Janardhanan e C.K. Balagopalan presso la Kalakshetra, e Meena Raman. In India approfondisce lo studio della musica carnatica e della ritmica con il cantante e compositore B. Seetharama Sarma. Da diversi anni si esibisce in ambito nazionale ed internazionale, come solista o in collaborazioni artistiche, con la compagnia Mangalam di Maresa Moglia, Mavin Khoo (Big Dance 2006 Londra). Nel 2012 vince il premio del pubblico al concorso di danza contemporanea Giovani Danze d’Autore, Veneto, con lo spettacolo mono-dia-loghi ritmici (di N. Biondi e M. Zavan) e partecipa con menzione speciale al Roma Europa Festival.
Il Bharata Natyam è uno dei generi più importanti di spettacolo classico indiano. La sua origine è relativamente recente: si tratta infatti di una riscrittura scenica novecentesca — databile tra gli anni venti e trenta — dell’antica danza sacra eseguita nei templi hindu del sud dell’India dalle devadasi, le “ancelle del dio”, conosciute in Occidente anche con il nome di baiadere (dal portoghese balhadeira, “ballerina”). Il Bharata Natyam fu il frutto dell’ appassionato lavoro di ricerca di un gruppo di intellettuali e di artisti indiani – fra cui Krishna Iyer e Rukmini Devi — che, coadiuvati da alcune anziane devadasi e dai maestri di danza tradizionale – i nattuvanar –, riorganizzarono ciò che in epoca coloniale era sopravvissuto della tradizione performativa sacra. Essi integrarono le informazioni raccolte sul campo con quelle provenienti dalla lettura degli antichi trattati teatrali e dallo studio delle pose sceniche immortalate nei bassorilievi dei templi. In questo modo fu “reinventata la tradizione” e nacque il Bharata Natyam, cioè “la danza di Bharata”, il primo leggendario danzatore indiano che, secondo il mito, ebbe per maestro lo stesso Shiva, il dio del teatro e della danza.
Il Bharata Natyam unisce le tre qualità fondamentali del teatro classico indiano: Bhava (la rappresentazione degli stati d’ animo), Raga (la melodia, il canto), Tala (il ritmo, il tempo). Da un punto di vista strettamente coreografico si tratta di una danza solista che si compone di due aspetti principali: la danza pura o nritta, che non ha alcun significato, non esprime alcun sentimento, ed è dominata dalla musica e dai suoi ritmi, e la danza drammatica o abhinayam in cui prevale l’ elemento mimico, il gesto e l’ espressione. L’ orchestra tradizionale è costituita generalmente da una vina (l’antica chitarra indiana), cimbali, tamburi e un flauto. Anche la musica vocale ha una funzione fondamentale dato che durante i passaggi drammatici i canti vengono tradotti con estrema precisione nel linguaggio dei gesti (hasta mudra). I danzatori e le danzatrici di Bharata Natyam sono dei veri e propri “narratori gestuali”, dei mimi eccezionali in grado di esprimere — attraverso maschere facciali codificate — gli stati d’animo fondamentali dell’essere umano. Le canzoni hanno quasi sempre carattere devozionale e sono ispirate da un sincero sentimento mistico. Espongono in versi temi religiosi, eroici o filosofici basati sulle leggende sacre hindu. L’interpretazione gestuale e mimica di questi versi non è fissata una volta per tutte. Di uno stesso verso infatti il danzatore o la danzatrice può offrire, anche all’interno del medesimo spettacolo, interpretazioni differenti e perfino contrastanti tra di loro. Uno degli aspetti più affascinanti del Bharata Natyam è proprio la libertà lasciata all’artista di improvvisare le variazioni, di creare una propria poesia gestuale all’interno di una struttura di movimento altamente codificata.
L’arangetram, il debutto sulla scena, viene celebrato a conclusione di un lungo ciclo di studi presso un maestro. Tale apprendimento riguarda non solo la conoscenza dell’arte della danza ma anche quella delle buone maniere, della grammatica, della raffinatezza estetica, tutte qualità tipiche dell’aspetto “lasya” o “delicato” che caratterizza il Bharata Natyam. Il termine arangetram deriva da arangam o “palcoscenico” e da etram, che significa “raggiungere o scalare”. Anticamente il vocabolo indicava il rituale di consacrazione delle devadasi e segnava il loro ingresso nella professione di danzatrici sacerdotesse del dio Shiva presso un tempio o presso la corte di un sovrano. Secondo la tradizione hindu, la cerimonia dell’ arangetram dovrebbe iniziare con il calare del sole, un momento del giorno considerato proficuo e altamente simbolico: il tramonto segna infatti per l’iniziato la fine di una fase dell’esistenza e l’inizio di una “vita nuova”.