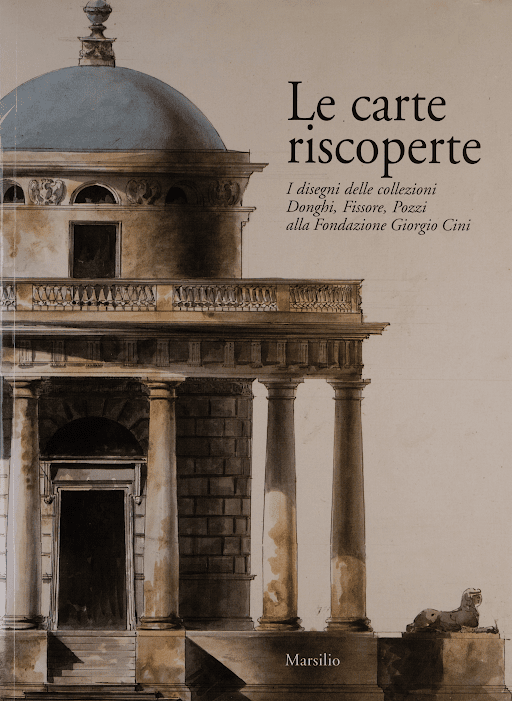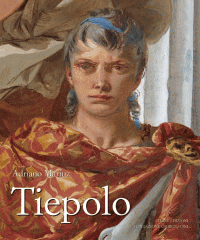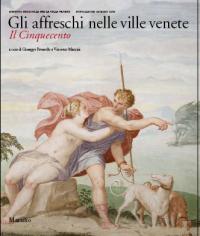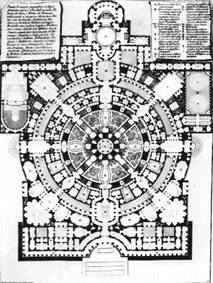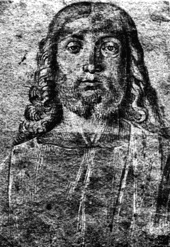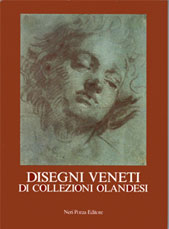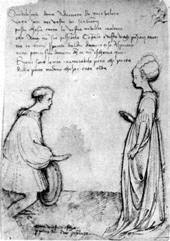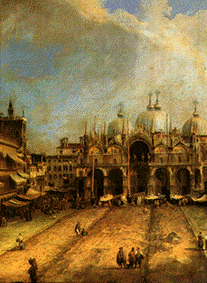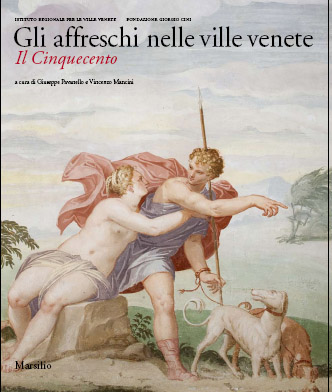Per la prima volta la Fondazione Giorgio Cini presenta una folta serie di dipinti di uno dei più grandi artisti di Venezia: Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto (1697 -1768).
La mostra espone 41 dipinti di primissima scelta, collaudati senza incertezza dalla tradizione critica e quasi tutti provenienti da clienti o collezionisti del Settecento, per lo più inglesi, in contatto col Canaletto. Se si pone mente alle sempre più gravi difficoltà incontrate dagli organizzatori di mostre d’arte antica, la riunione di 41 dipinti del Canaletto all’Isola di San Giorgio acquista un valore eccezionale, dimostrando il credito che la Fondazione Giorgio Cini gode presso i paesi stranieri, soprattutto anglosassoni.
La mostra inoltre espone una scelta di ben 75 disegni (di cui 25 provenienti dalle Collezioni Reali di Windsor), che offrono la lettura di ogni aspetto dell’attività disegnativa del Canaletto (dallo «scaraboto» al disegno preparatorio, pronto ad essere tradotto a colori): tra l’altro Alessandro Bettagno è riuscito a riunire 9 dei 10 grandi fogli preparatori delle Feste Dogali. Inoltre sono presenti non solo tutte le incisioni del Canaletto scelte negli esemplari più freschi, ma nei diversi stati (primo, secondo, terzo e – talvolta – quarto).
Sono stati assicurati alla mostra due dipinti del Canaletto di collezione privata italiana già apparsi nella mostra del 1967, ma necessari per rendersi conto del senso dello spettacolo, raffiguranti il Ricevimento dell’ambasciatore imperiale conte di Bolagno e la Festa della Sensa.
Un esempio perspicuo della sensibilità canalettiana rivolta a captare lo spazio in un gioco serrato di valori pittorici, è la Veduta del Bacino di San Marco del Museo di Boston, certamente uno dei suoi capolavori in assoluto, raggiunto poco prima del 1740, in piena armonia con il momento più luminoso della pittura veneziana, dal Tiepolo al Piazzetta.
La serie delle acqueforti dedicate al console ed amico Joseph Smith, con il titolo significativo: Vedute, altre prese da i Luoghi altre ideate… (la cui esecuzione va dal 1740 al 1744 circa), si inserisce nello sviluppo artistico del Canaletto non come parentesi marginale, ma come un momento essenziale di alcuni problemi stilistici, che troveranno la loro piena realizzazione nei primi capolavori eseguiti nel soggiorno inglese.
La serie raggruppa fogli che evocano un itinerario che partendo dalla laguna, cioè da Marghera, passando per Mestre, risale il corso del Brenta fino a Padova, non solo inscenata nel cosmorama del Prà della Valle ma in una veduta che segna il passaggio tra la realtà dei luoghi e la fantasia del capriccio. Se il Portico con la lanterna, indubbiamente una delle prove più alte dell’arte incisoria del Canaletto, è una veduta di piena fantasia, l’acquaforte con la cosiddetta Casa del 1741, ricongiunta con la Casa del colonnato, è l’evocazione di una città, che se pur manca di precisi riferimenti topografici, è intrisa di atmosfera veneziana.
Alle quattro vedutine veneziane «prese dal vero», ne seguono altre pure di piccolo formato «ideate», tra le quali i quattro stupendi paesaggi di fantasia, che, tra l’altro, costituiscono una sorpresa nella sequenza delle incisioni per la libertà con la quale il Canaletto si sottrae all’impegno tecnico che aveva fino ad allora strutturato il suo linguaggio, qui sciolto in una rapidità di segno quasi provvisoria, rapidissima, stracciata.
Bettagno è riuscito a raddoppiare il numero delle vedute inglesi esposte alla mostra canadese del 1964 ed a quella di Palazzo Ducale del 1967, esponendo una serie di straordinari esempi di vedute e di paesaggi che il Canaletto ha dipinto in tale soggiorno: dal Ponte di Westminster di collezione privata inglese, dove l’impaginazione panoramica è ravvivata da un’emergenza di notazioni luminose che imprimono all’assieme una vibrazione intensissima, al non meno straordinario Ponte di Walton della Galleria di Dulwich, dove il curioso ponte di legno chiarissimo prende uno stacco irreale sulle tonalità grigio-brunacee calde dell’assieme.
Un’altra ghiotta attrattiva di questa mostra è la presenza delle quattro Vedute veneziane che il Canaletto dipinse per Sigismund Streit, oggi conservate negli Staatliche Museen di Berlino- Dahlem. La vigilia di S. Pietro di Castello e l’altra di S. Marta sono due notturni che costituiscono certamente due tra le più straordinarie esperienze luministiche tentate dal Canaletto in questo ultimo periodo della sua attività.
A sottolineare la fondamentale esperienza luministica canalettiana, Bettagno ha presentato alla mostra due Interni di San Marco delle Collezioni Reali di Windsor che possono considerarsi esempi della ricerca luministica canalettiana. L’aver messo i’accento sulla ricerca «luministica» dell’ultimo Canaletto costituirà certamente un altro merito di questa mostra.