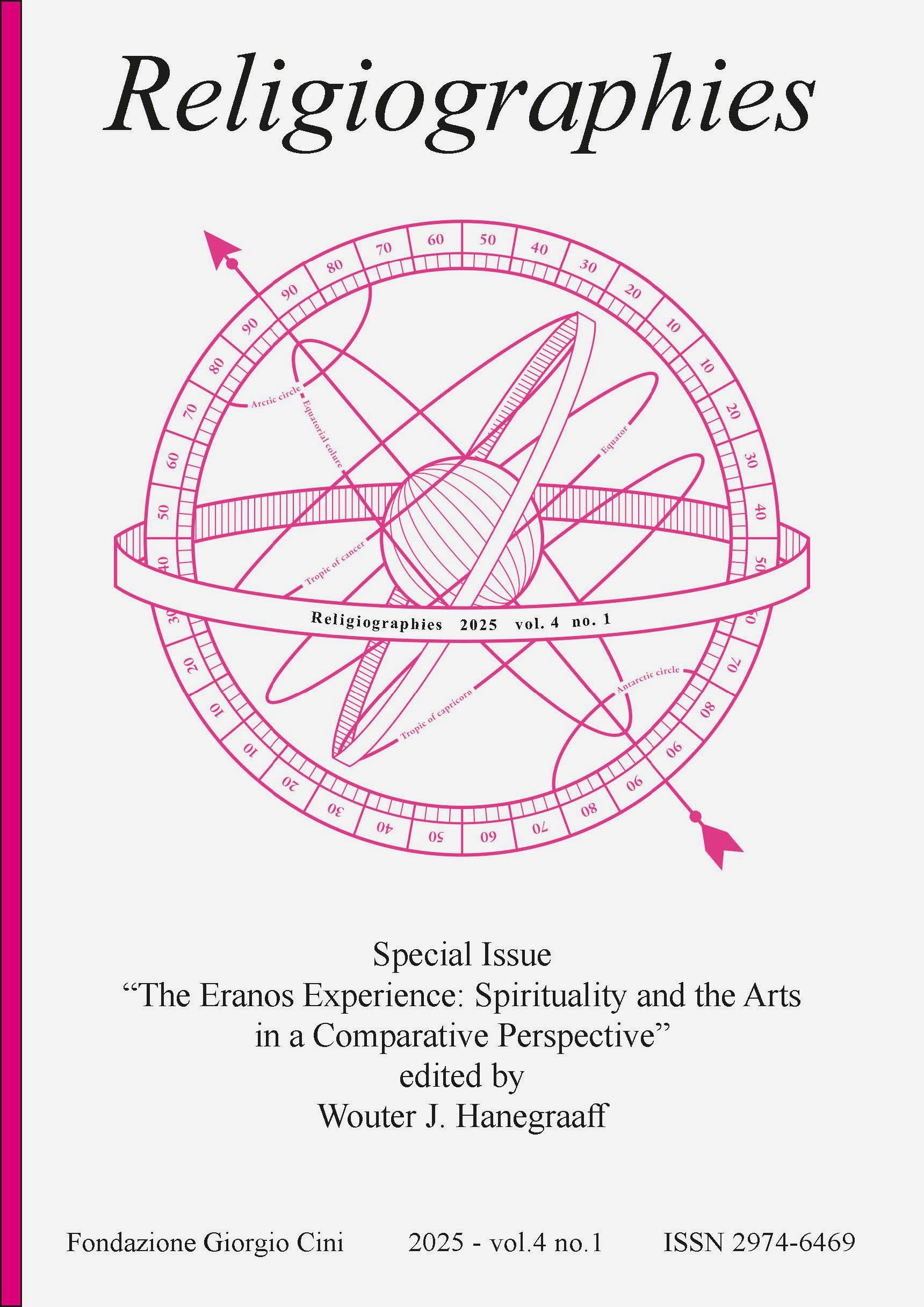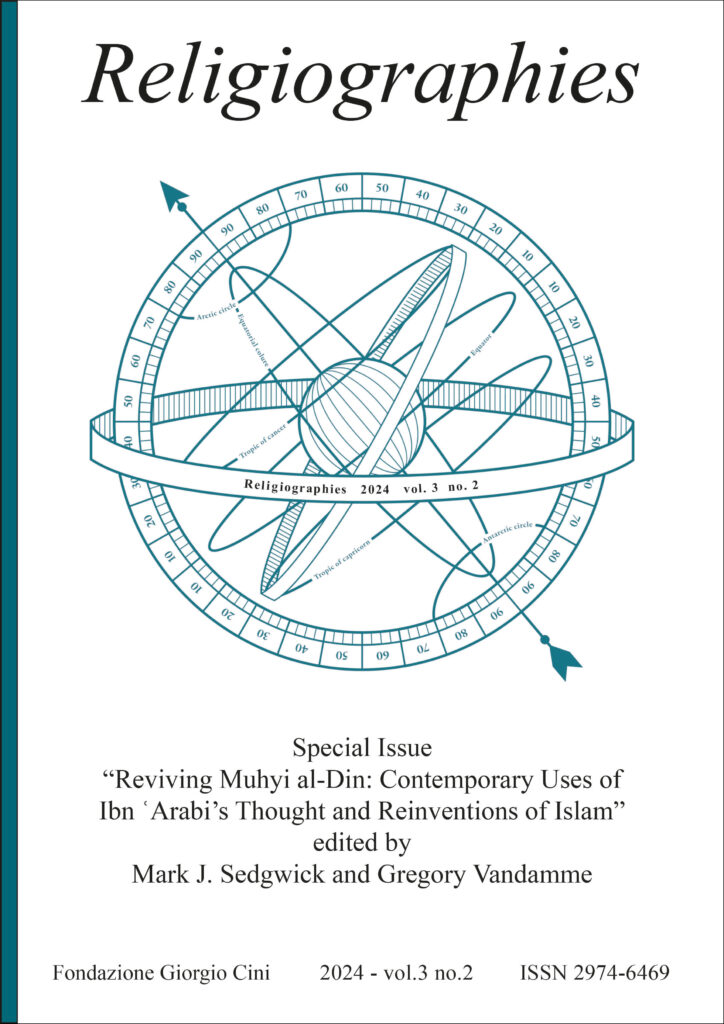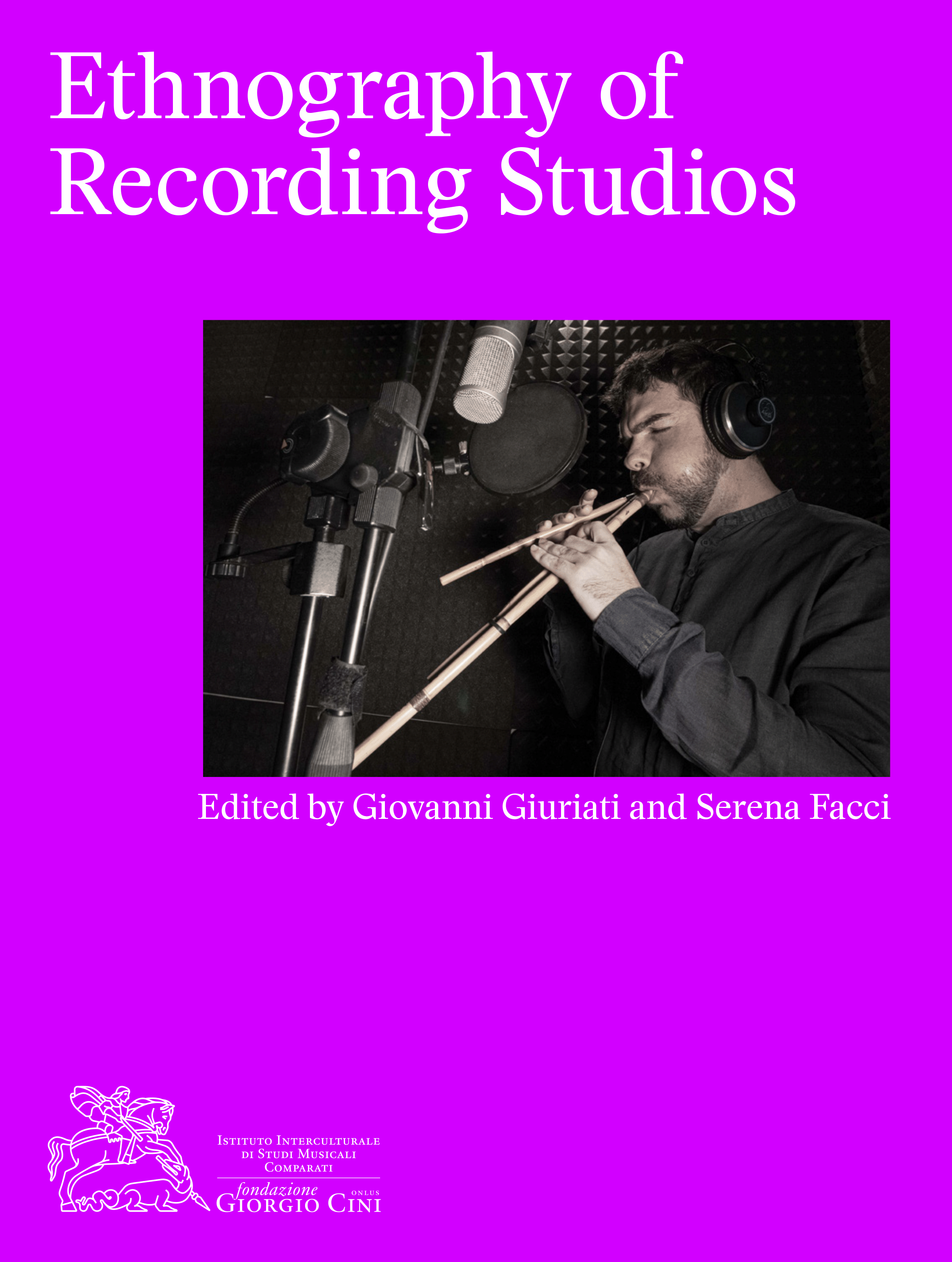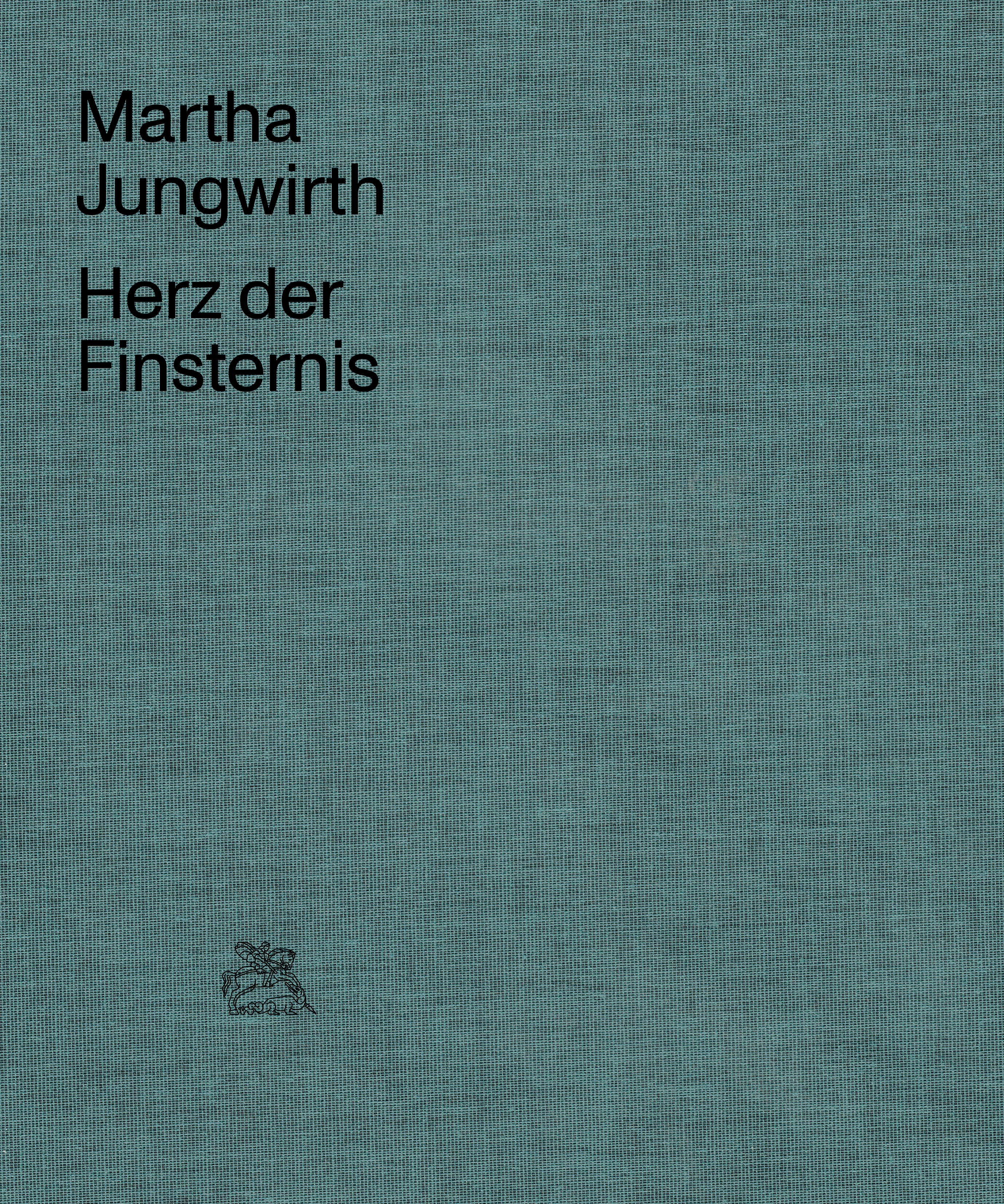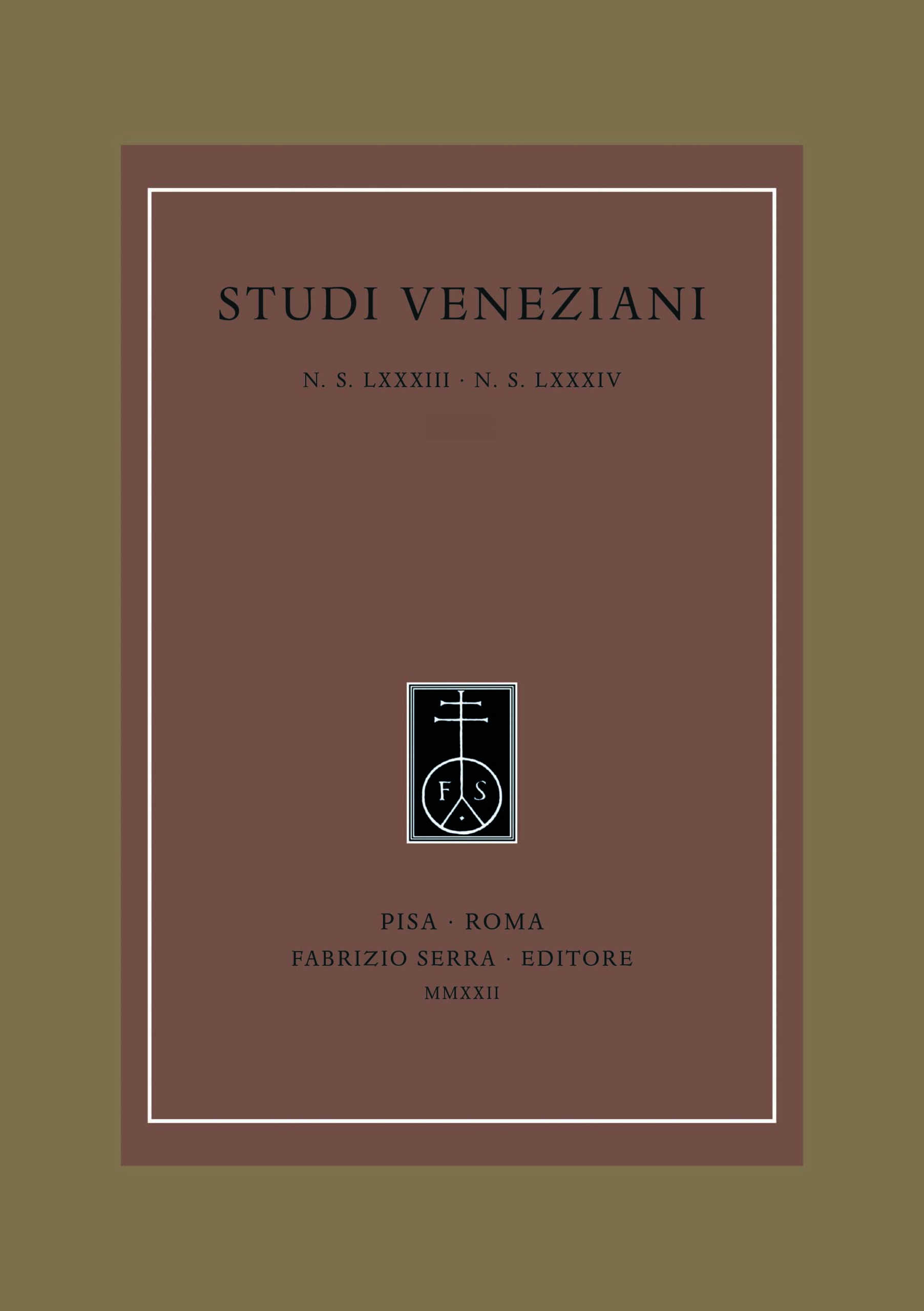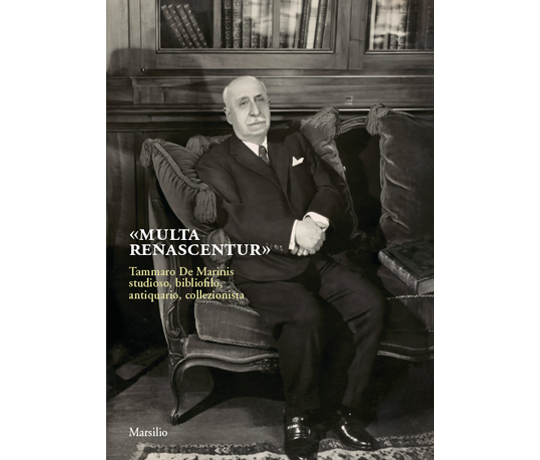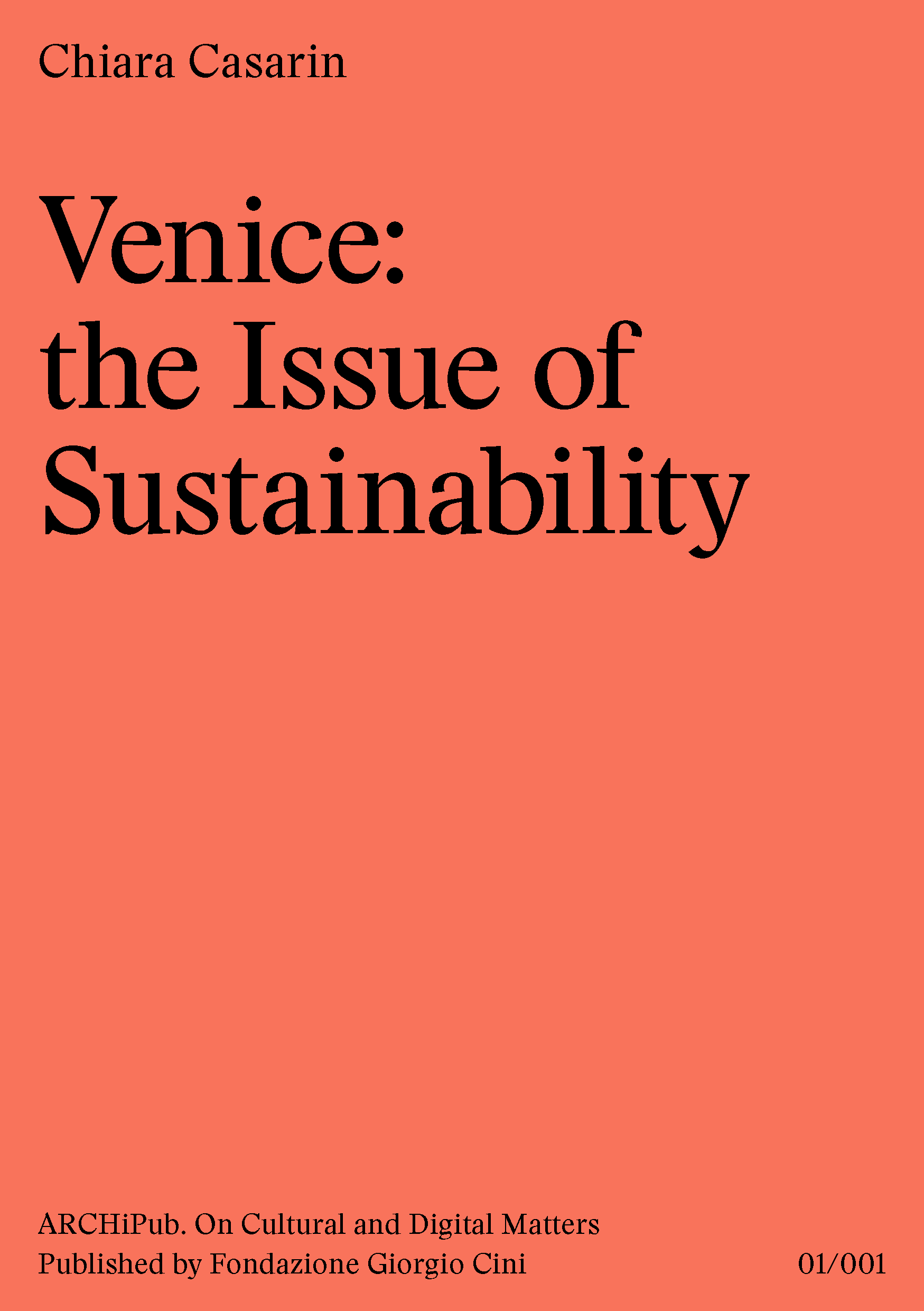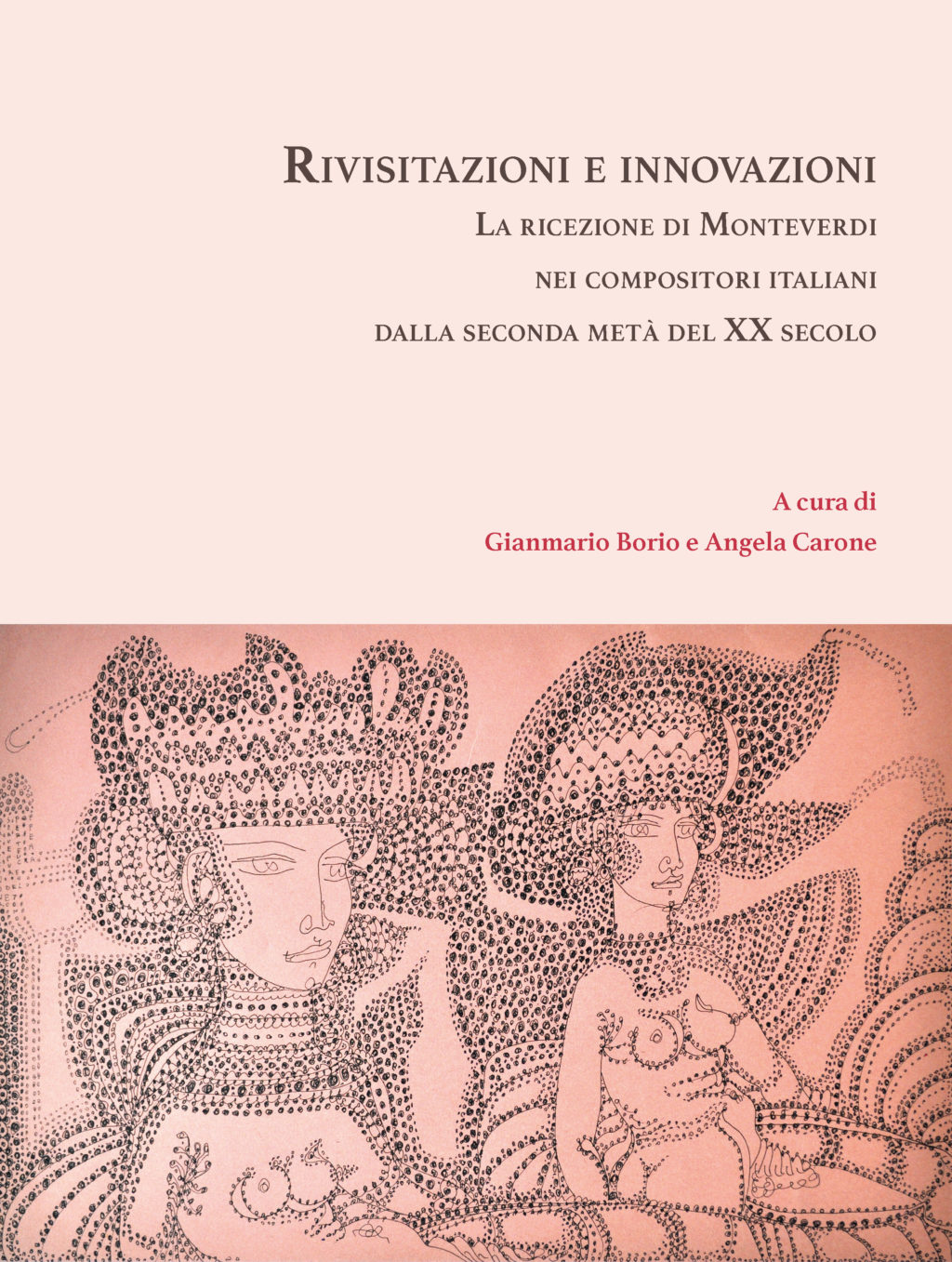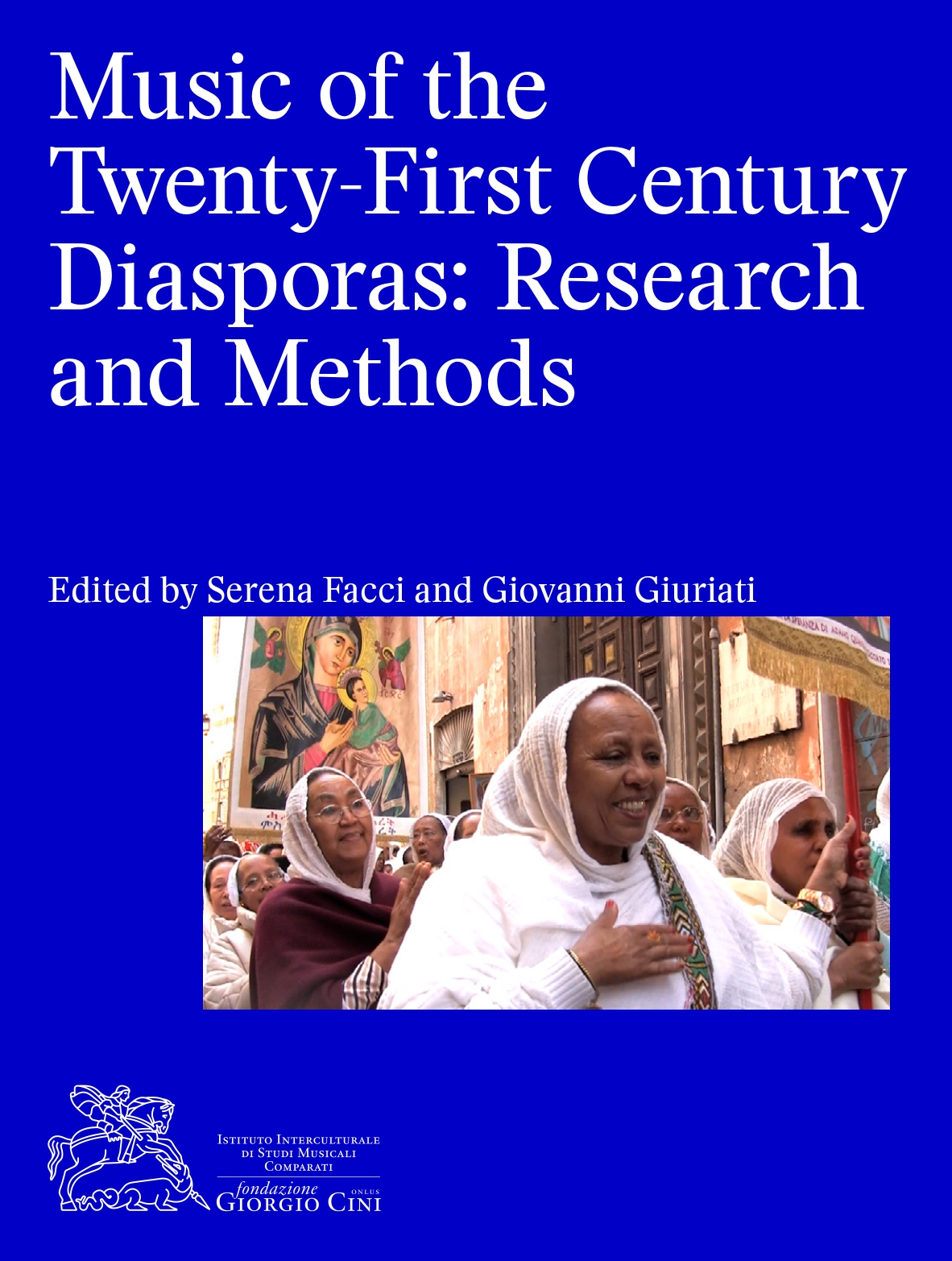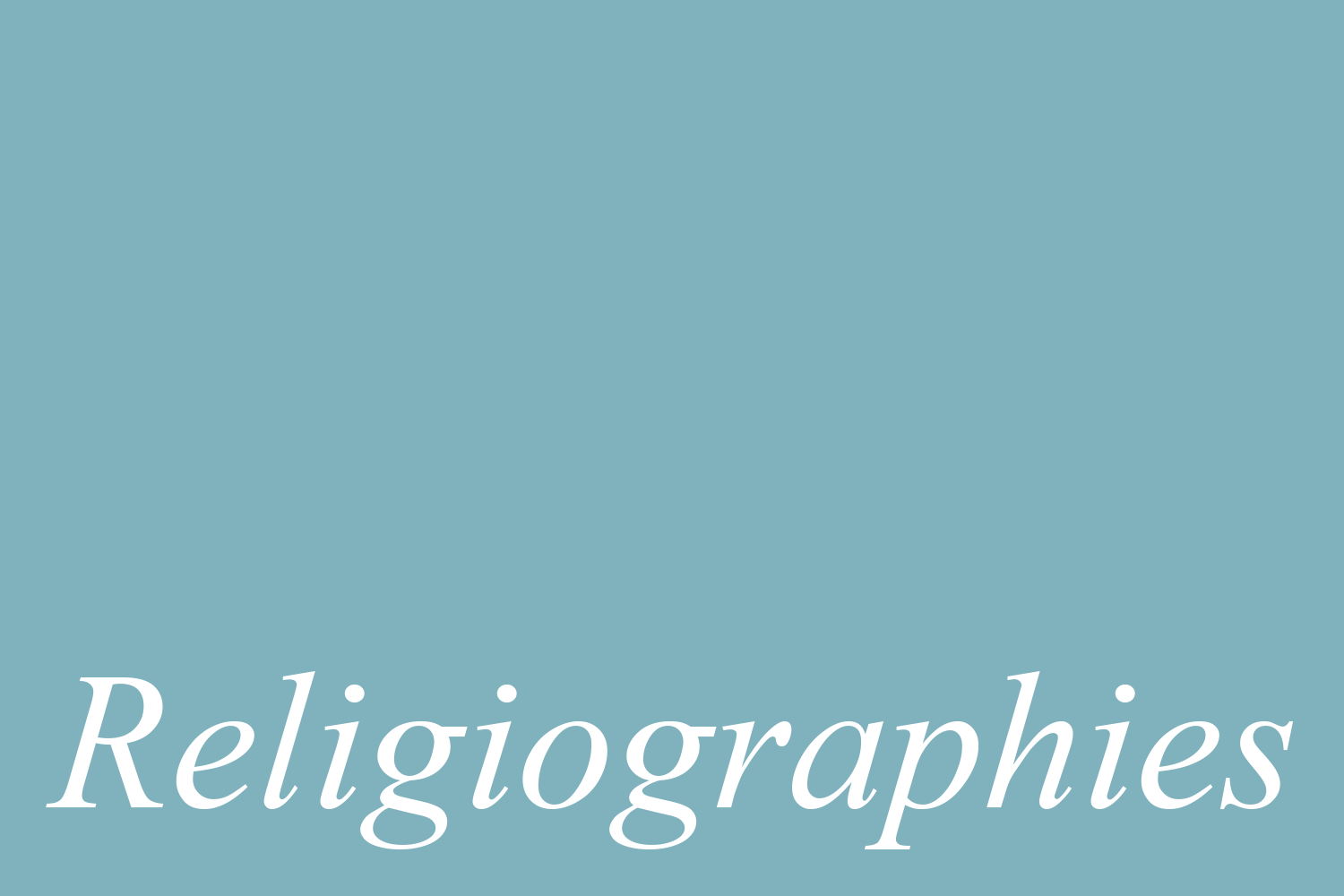Rivista open-access e peer-reviewed, curata dal Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate della Fondazione Giorgio Cini.
Religiographies si dedica allo studio dei fenomeni religiosi, promuovendo un dialogo interdisciplinare tra storici, sociologi, antropologi, filosofi e psicologi. Misticismo, esoterismo e spiritualità sono i tre temi principali della rivista, che vengono esplorati nel loro contesto storico e culturale, mettendo in discussione le categorie tradizionali della religione. La sezione heterographie, dedicata a opere artistiche e visive, amplia la comprensione dei fenomeni trattati.
[accordion][/accordion]
[accordion_entry title=”Obiettivi e ambito”]
Religiographies è una rivista open-access e peer-reviewed dedicata allo studio dei fenomeni religiosi e pubblicata sotto il patrocinio del Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate della Fondazione Giorgio Cini. Dal 2025 è stata riconosciuta dall’ANVUR (agenzia del ministero dell’istruzione) come rivista scientifica per l’Area 11 (scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Religiographies mira a promuovere un approccio interdisciplinare, promuovendo il dialogo tra storici, sociologi, antropologi, studiosi letterari, filosofi e psicologi.
Inoltre, puntiamo a discutere quei temi che sono spesso trascurati dalle scienze sociali e umane – come il misticismo, l’esoterismo, la spiritualità – che, secondo le parole di Michel de Certeau, “perseguitano l’epistemologia scientifica”. Il nostro obiettivo non è quello di creare un’altra rivista sulle spiritualità alternative, ma di riportare questi temi al centro del dibattito sui fenomeni religiosi e culturali.
Incoraggiamo a decostruire e contestare le categorie – inclusa la parola stessa “religione” – non come un esercizio di stile, ma come pratica, mostrando con i dati raccolti sul campo, la porosità, permeabilità e la fragilità delle nostre categorie. Inoltre, miriamo a promuovere una storia antropologica e allo stesso tempo una socio-antropologia con una forte enfasi storica, con l’intenzione di evitare sia il presentismo socio-antropologico che una storia focalizzata solo su idee e istituzioni, ignorando la materialità, le emozioni, la vita quotidiana.
Infine, con il concetto di “etero-grafie” – rappresentazioni diverse – intendiamo dare spazio ad altre forme di rappresentazioni, come la fotografia, l’illustrazione, i video e le opere d’arte. Questi altri linguaggi permetteranno ai nostri autori – studiosi e artisti – di esplorare dimensioni al di là del quadro dell’oggettività e della coerenza proprie delle scienze sociali. Questa sezione, chiamata heterographies, non è strettamente scientifica: non sarà peer-reviewed, ma riceverà dei suggerimenti dagli editori e da altri autori.
Invitiamo la presentazione di articoli su tutti i fenomeni religiosi, con particolare attenzione a:
- Approcci comparativi;
- trasferimenti culturali: acculturazione, appropriazione, immaginazione;
- continuità e discontinuità tra discorsi religiosi e pratiche di vita quotidiana;
- prospettiva trans-storica, sottolineando le connessioni tra vecchie e nuove tendenze;
- fenomeni liminali tra il “secolare” e il “religioso”;
- il rapporto con l’alterità, inteso non solo come religioso, ma anche in termini di genere,
orientamento sessuale ed etnia;
- fenomenologia del corpo religioso: percezioni, emozioni, sensazioni e costruzione del corpo;
- dibattiti epistemologici e metodologici sulla trasferibilità e traducibilità delle categorie
di studi religiosi.
[/accordion_entry]
[accordion][/accordion]
[accordion][/accordion]
[accordion_entry title=”Comitato Editoriale”]
Editor-in-chief
Francesco Piraino, Fondazione Giorgio Cini / Harvard Divinity School
Editors
Mark Sedgwick , University of Aarhus
Dionigi Albera, CNRS-IDEMEC
Assistant editors
Elena Bernardinello, Fondazione Giorgio Cini
Eva Salviato, Fondazione Giorgio Cini
Copy editor and proofreader
Anna Fitzgerald
Book Reviews
Valentina Gaddi, Université de Montréal
Editorial board
Stefano Allievi, University of Padua
Egil Asprem, University of Stockholm
Katell Berthelot, CNRS–Aix-Marseille University
Francesco Cerchiaro, Radboud University
Andrea De Antoni, University of Kyoto
John Eade, University of Roehampton
Diana Espírito Santo, Universidad Catholica de Chile
Fabrizio Ferrari, University of Padua
Mattia Fumanti , University of St. Andrews
Giuseppe Giordan, University of Padua
Alberta Giorgi, University of Bergamo
Boaz Huss, Ben Gurion University
Salvatore La Mendola, University of Padua
Marco Pasi, University of Amsterdam
Enzo Pace, University of Padua
Stefania Palmisano, University of Turin
Vadim Putzu, Missouri State University
Khalid Razzhali, University of Padua
Antonio Rigopoulos, University of Ca’ Foscari
Armando Salvatore, University of McGill
Chiara Tommasi, University of Pisa
Fabio Vicini, University of Verona
[/accordion_entry]
[accordion][/accordion]
[accordion][/accordion]
[accordion_entry title=”Religiographies vol.4″]
Religiographies vol.4 n.1 (2025)
[/accordion_entry]
[accordion][/accordion]
[accordion][/accordion]
[accordion_entry title=”Religiographies vol.3″]
Religiographies vol.3 n.2 (2024)
Religiographies vol.3 n.1 (2024)
[/accordion_entry]
[accordion][/accordion]
[accordion][/accordion]
[accordion_entry title=”Religiographies vol.2″]
Religiographies vol.2 n.2 (2023)
Religiographies vol.2 n.1 (2023)
[/accordion_entry]
[accordion][/accordion]
[accordion][/accordion]
[accordion_entry title=”Religiographies vol.1″]
Religiographies vol.1 n.1 (2022)
[/accordion_entry]
[accordion][/accordion]