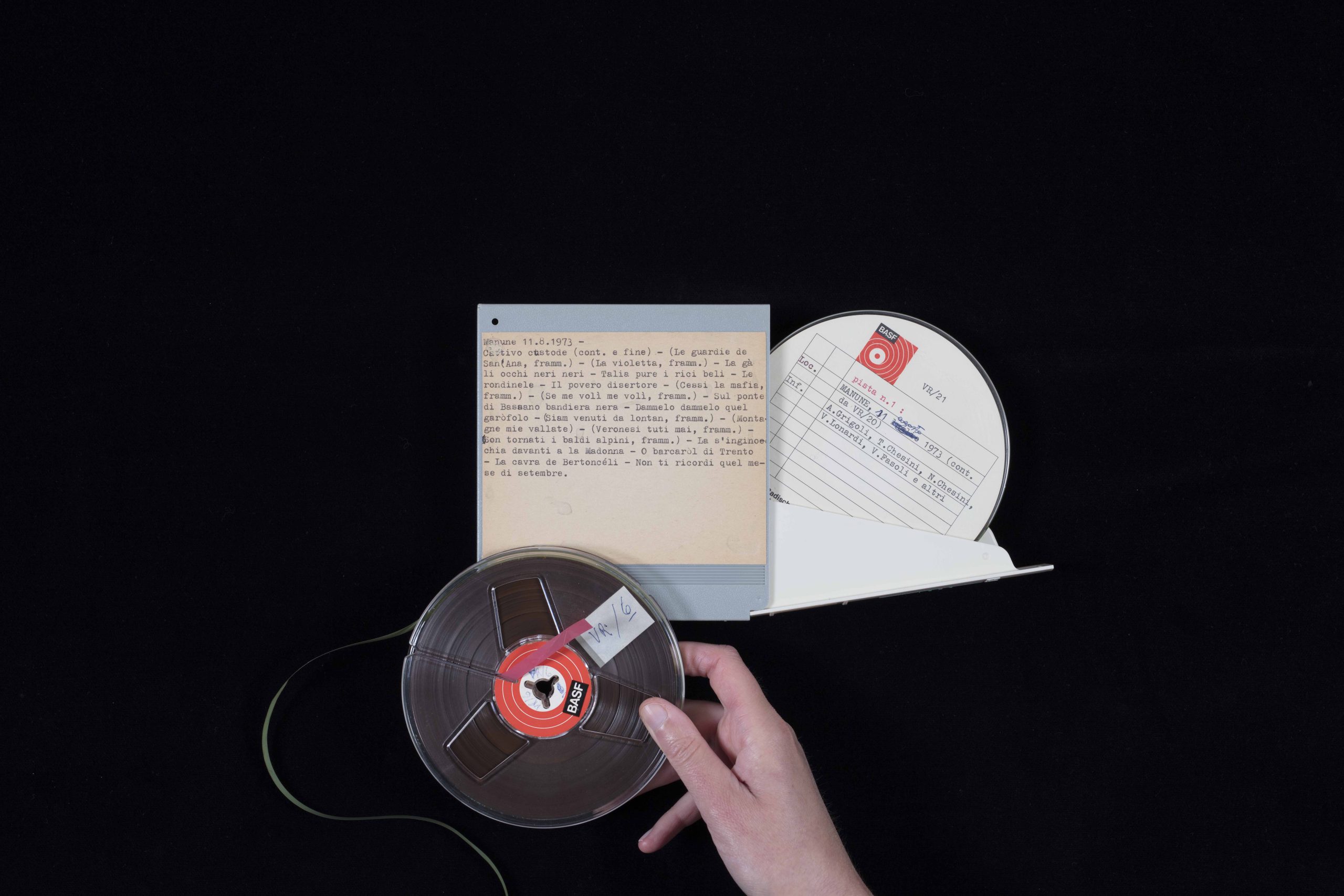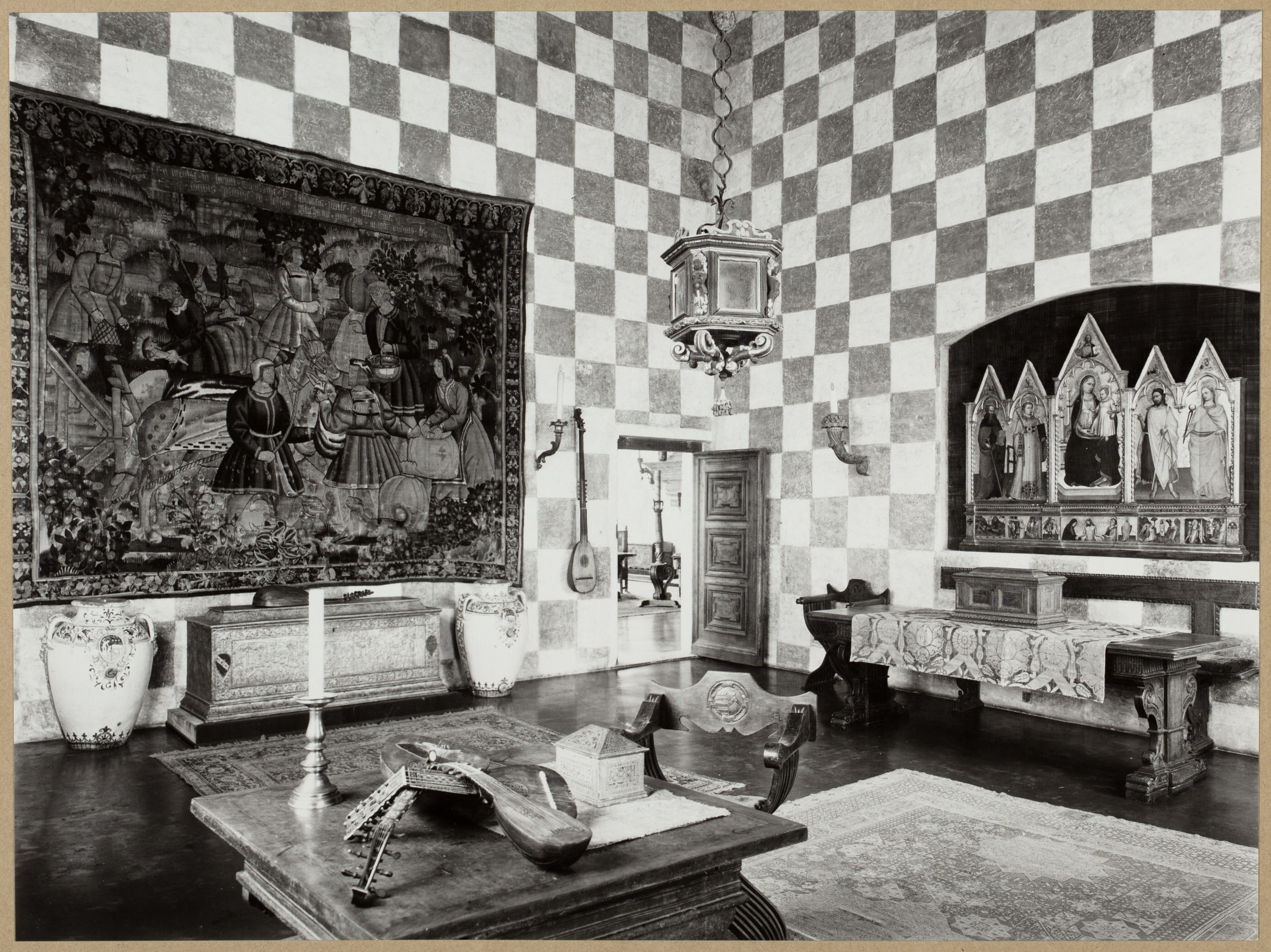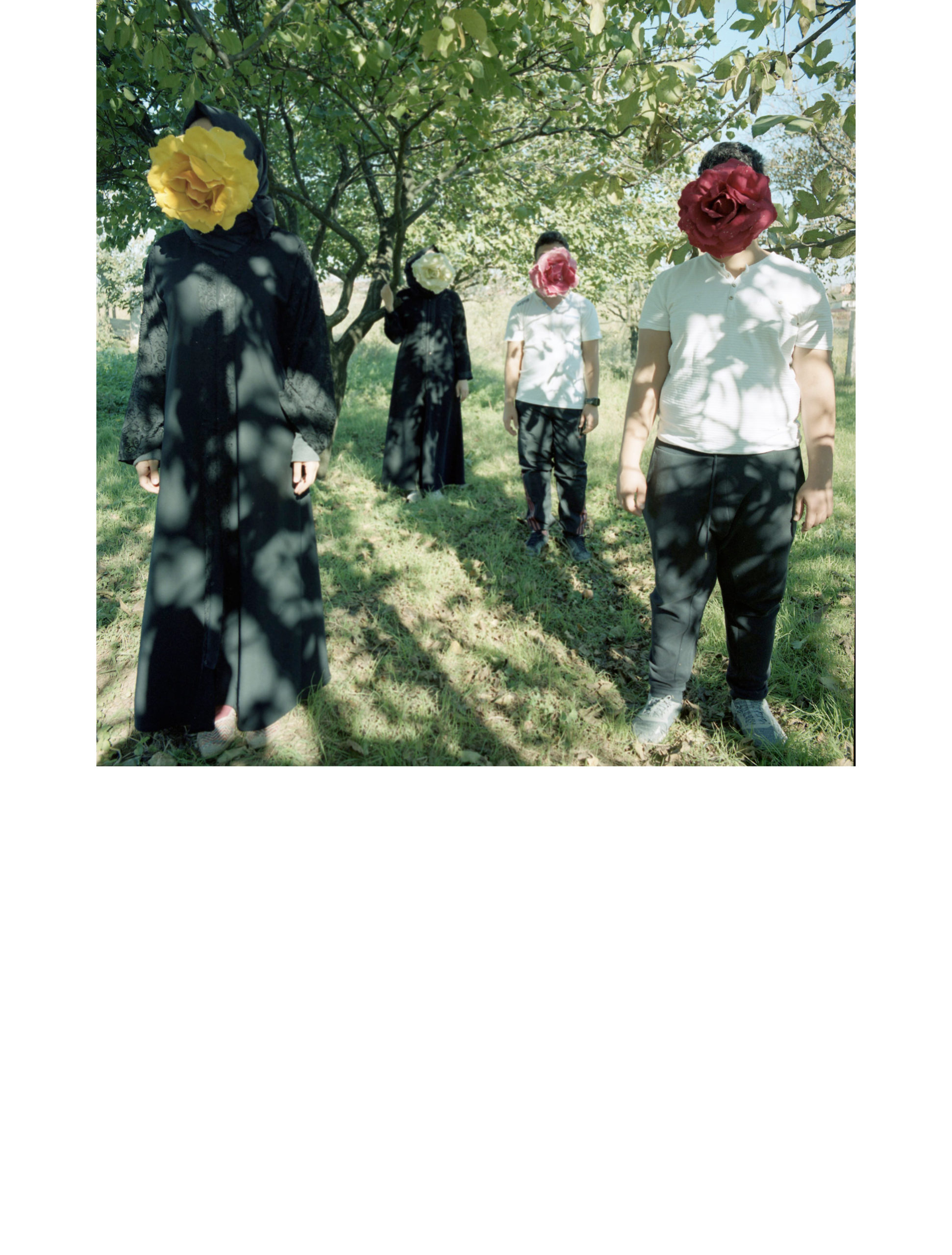Il seminario è a cura di Giacomo Albert e Laura Zattra, coordinatori del gruppo di ricerca RISME digitali della Società Italiana di Musicologia.
La locuzione “composizione assistita” ha preso piede negli anni Ottanta del secolo scorso per designare un insieme di esperienze le cui radici risalgono ai tre decenni precedenti, agli albori delle applicazioni digitali in musica. Questo approccio, che in origine è legato alla composizione algoritmica e alla modellazione computazionale delle strutture musicali, si è esteso a indicare una serie ampia e variegata di strumenti digitali di assistenza, applicati in diverse fasi del processo compositivo.
Sebbene le pubblicazioni di impostazione tecnica sulla composizione musicale assistita dal computer siano cospicue, la saggistica musicologica si è finora limitata a studi specifici senza offrire una prospettiva globale. Il seminario si propone come primo passo per colmare questa lacuna. La composizione assistita sarà studiata nella prospettiva dell’interazione uomo-macchina; il gruppo di ricerca esplorerà le modalità in cui i compositori adoperano gli strumenti digitali e formulerà ipotesi sulle ripercussioni della loro architettura per la scrittura e le strutture musicali.
Il seminario sarà organizzato in tre sessioni: nella prima tre musicologi discuteranno sul rapporto tecnologia-scrittura in specifici casi studio, nella seconda lo sguardo sarà rivolto all’interazione uomo-macchina nel suo complesso e alle radici filosofiche della “composizione assistita”, infine, nella terza, tre compositori e assistenti musicali rifletteranno sulla loro esperienza alla luce anche delle discussioni precedenti.
Parteciperanno Joshua Banks Mailman, Marc Battier, Agostino Di Scipio, Carl Faia, Jonathan Impett, Sanne Krogh Groth, Marco Stroppa, Martin Supper, Elena Ungeheuer.
Scarica il programma del seminario
Per iscriversi compila il seguente form