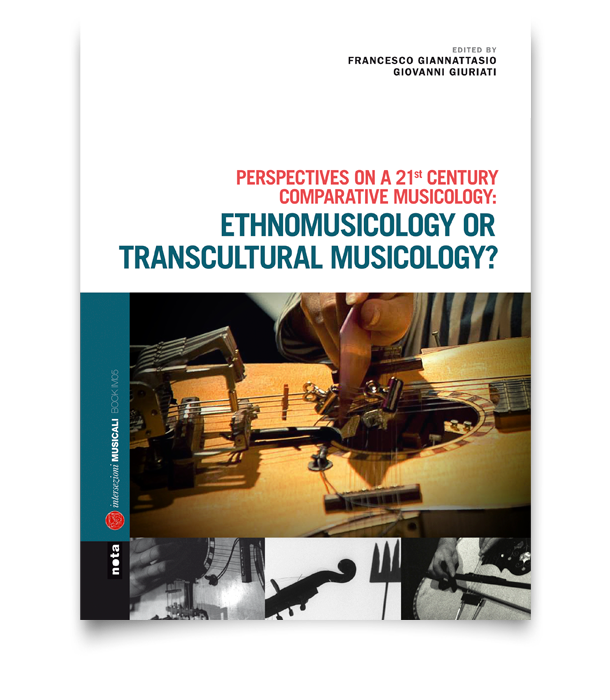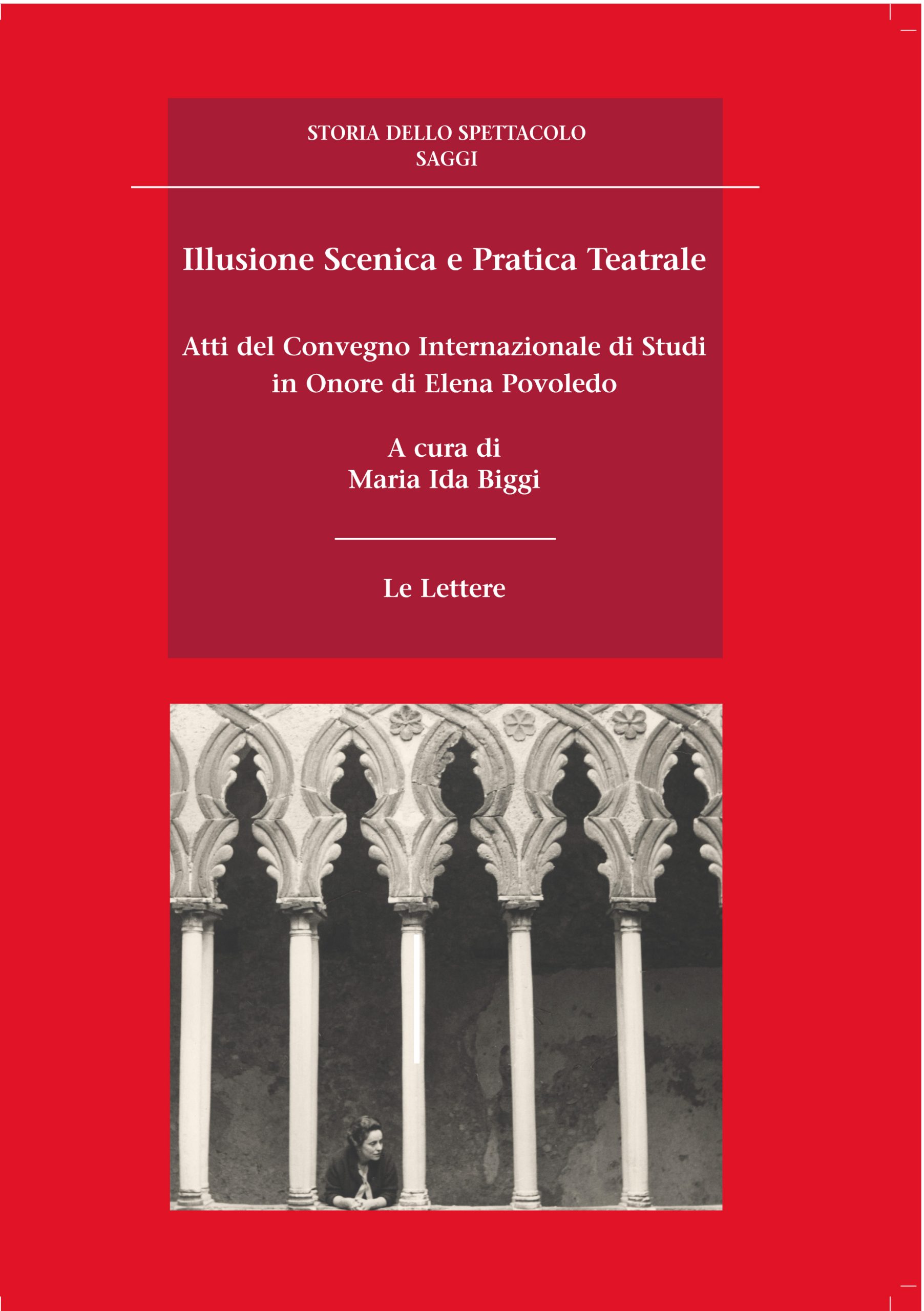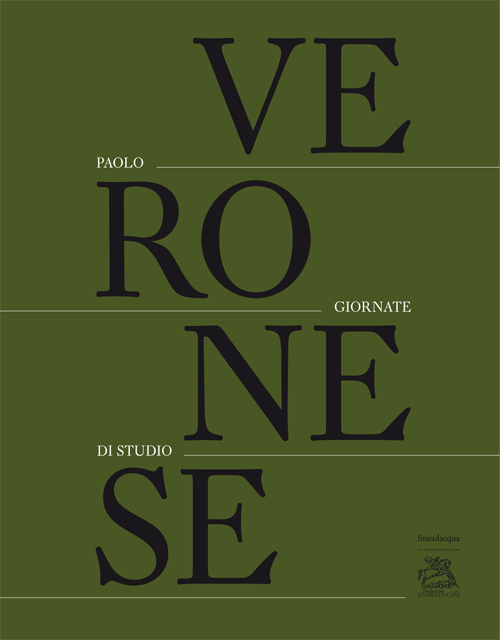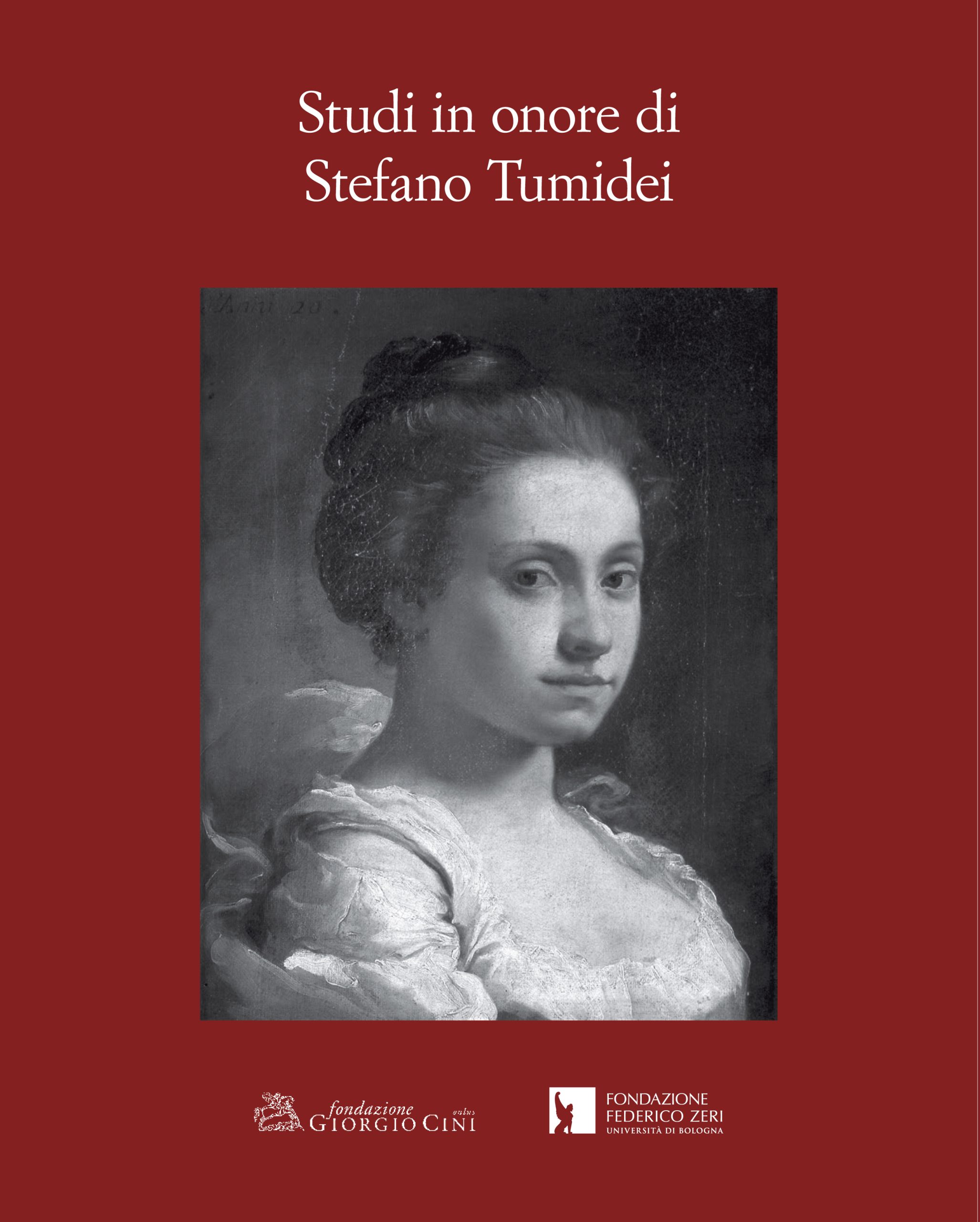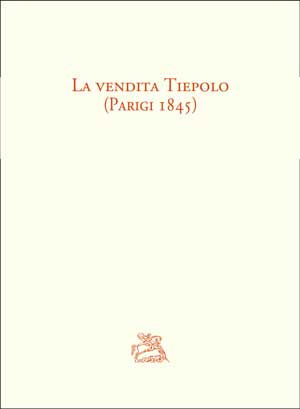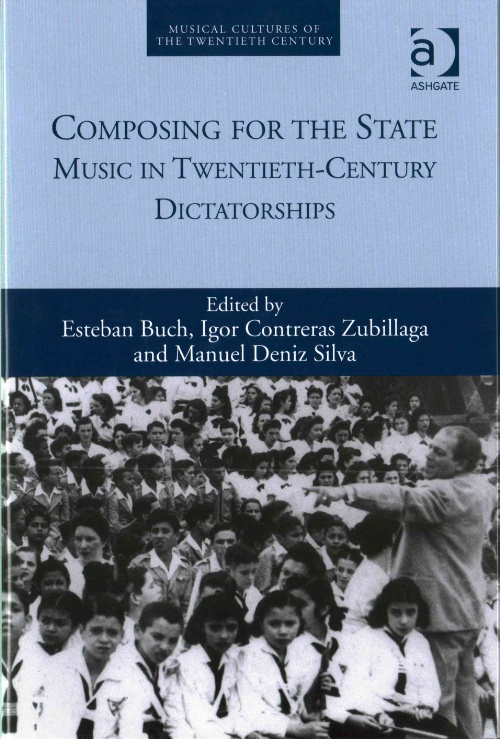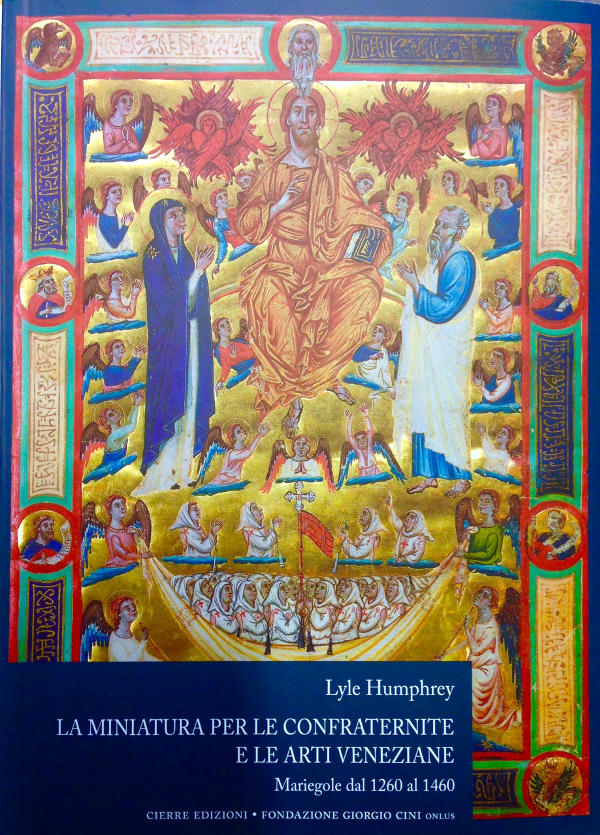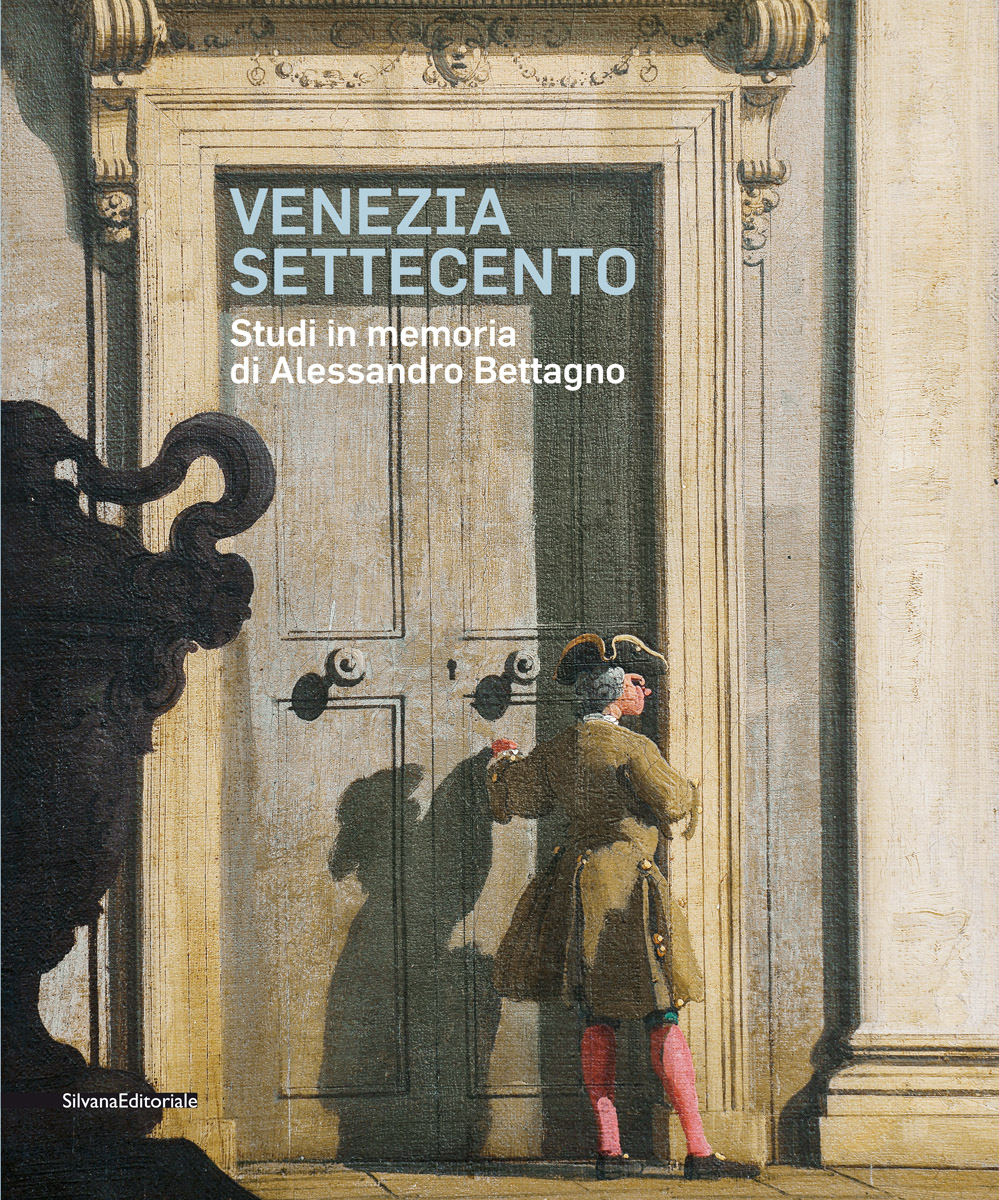Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: Ethnomusicology or Transcultural Musicology?
Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: Ethnomusicology or Transcultural Musicology? è un volume che prende le mosse dalle ultime tre edizioni (2013-2015) del Seminario internazionale di etnomusicologia organizzato annualmente dall’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati (IISMC), curato per un ventennio da Francesco Giannattasio. Il volume – a cura di Francesco Giannattasio e Giovanni Giuriati ed edito nella collana Intersezioni Musicali promossa dall’IISMC in collaborazione con l’editore Nota – raccoglie alcuni degli interventi di quei seminari, ampiamente rivisti per la pubblicazione.
Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: Ethnomusicology or Transcultural Musicology? scaturisce da un’ampia riflessione riguardante le finalità, le metodologie e gli oggetti di studio dell’etnomusicologia alla luce dei profondi cambiamenti che interessano attualmente tale campo di studio. In particolare, si propone di affrontare un generale ripensamento – a livello teorico ed epistemologico – della storia della disciplina, con l’ambizione di offrire elementi di riflessione e analisi sul contributo che una nuova musicologia transculturale può offrire oggi all’indagine delle pratiche musicali contemporanee nel mondo.
La prima parte del volume è dedicata all’inquadramento di diversi possibili approcci teorici per lo studio delle musiche contemporanee in una prospettiva globale, comparativa e transculturale: alle sollecitazioni poste nel saggio introduttivo di Francesco Giannattasio rispondono nei loro interventi studiosi internazionali – e afferenti a diversi ambiti di studio – come Wolfgang Welsch, Lars-Christian Koch, Timothy Rice, Steven Feld, Jocelyn Guilbault e Jean-Loup Amselle.
Nella seconda parte del volume, diversi studiosi italiani (Giovanni Giuriati, Claudio Rizzoni, Giovanni Vacca, Raffaele Di Mauro, Maurizio Agamennone e Flavia Gervasi) presentano le loro riflessioni con riferimento alle rispettive ricerche effettuate in due contesti individuati come casi di studio: l’area della provincia di Napoli e quella del Salento.
(https://www.notamusic.com/prodotto/ethnomusicology-or-transcultural-musicology/)